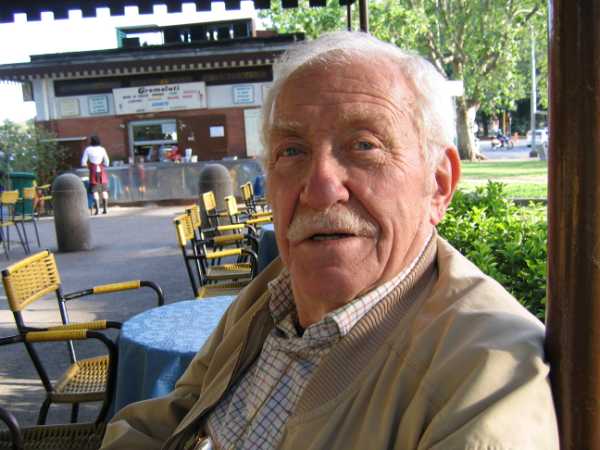Gian Piero Bona
Sandro Penna ovvero il miracolo della poesia
Mi faccio forza di una lettera che Umberto Saba scrisse a Penna il 4 Gennaio 1933: «Le tue poesie… mi sembrano un piccolo miracolo». E io aggiungo: Sandro Penna è forse l’unico miracolo della poesia italiana del Novecento.
Fu chiesto a Valery (non ricordo bene se è lui) quale fosse il più grande musicista. Beethoven, rispose. Ma come? E Mozart dove lo mette? Mozart, concluse, non è un musicista. È la musica stessa. Ecco: il senso della parola “miracolo”. Parafraso: Penna non è un poeta, è la poesia stessa.
È dunque, a mio avviso, imparagonabile agli altri, persino a Umberto Saba con il quale condivideva il poetare come «amore per la vita» (vedi il loro epistolario).
Ora, se egli è la poesia stessa, e la poesia è uno “stato indefinibile”, anche Penna è, in un certo senso, indefinibile.
Infatti egli si lamentava della “divina semplicità da poeta alessandrino” che gli attribuivano. Voleva essere piuttosto un «poeta del mistero».
E ci è riuscito. Oggi, da morto, più che mai sfugge ancora alla critica che ne cerca il «senso più vero e profondo al di là del godimento nella sua apparente facilità».
È un mistero. Bigongiari lo chiamava «un fiore con il gambo invisibile». Come fai a scoprire qualcosa di invisibile, di “indefinibile”?
La critica continua ad arrabattarsi su di lui. Continua a equivocarlo, perché si ferma al suo “equivoco”. Ma la poesia in Penna è più grande del poeta. Cioè, è più diversa della sua vita diversa.
Io credo che solo una nostra passione possa capirlo. Egli diceva «Voglio una passione gocciolante di viva passione …» Penna esorbita da ogni limite critico. Egli è fuori da ogni scuola e corrente. Egli fa buon gioco alle parole che Pound mi disse un giorno, quand’ero bambino: – Classico è essere eternamente giovane. E sai cosa vuol dire? Non adattarsi mai a certe definizioni critiche.
Ma sappiamo che Penna segna, da noi, la fine dell’età ermetica. E questo accade per quella “irregolarità cronologica” che in lui è un fatto precostituito al suo poetare. Irregolarità che si fa “impurità purissima” che viene fuori come un assoluto naturale.
Mi sono sempre riconosciuto nel discorso di Penna con gioiosa tranquillità. L’amico Elio Pecora chiosa appunto le mie poesie che vinsero il Premio Penna 1996, con parole così lusinghiere che vorrei trasferirle, personalmente, su Penna stesso. Ecco cosa dice: «Discende dalla nostra maggiore tradizione, da quel versante limpido che va finalmente assumendo il posto che le spetta nella storia letteraria e nell’empatia del lettore».
Ma io mi domando: quanto dovrà aspettare ancora questo [come dice bene Pecora] versante limpido? Visto che a Penna accade ancor oggi di venire escluso da certe cattive abitudini della critica, come del resto accade ai suoi discendenti.
Conservo cara una sua cartolina, la prima ricevuta negli anni Sessanta. Mi dice: «La leggo con tanta curiosità e piacere [Non lo dico che a chi lo merita, anzi, solo a chi merita molto di più! Come lei!] Il suo, ecc …» Vanità? Certo, me l’ha provocata lui, mettendomi dalla parte della sua “ambigua purezza etica e formale” che sembra ignorare l’esistenza di altre istituzioni.
Mi ha messo dalla sua parte e ne sono oggi felice. Dalla parte del suo “chiarore”, dei suoi magici capoversi: «Era l’alba sugli umidi colli». «Era il maggio felice, e tu, mia luna» (ecco lui umbro influenzato dal marchigiano Leopardi). «Era un mattino di un dolce gennaio». «Era il battello carico di luce». E ancora: «Era il paese della luce d’oro». «Oh freschezza di luce, trasparente!»
Ma mi ha messo anche dalla parte della sua solitudine poetica, in questa era di pigia-pigia di poeti generici. Solitudine di chi “beve con ebbrezza lo spettacolo della vita”. Egli mi ha fatto capire che la “gioia di vivere non dipende da altro che da noi stessi”.
«Solarità come trionfo scandaloso», «Storia splendida di una nevrosi ossessiva», «Libertà che ci parla della sua lunga prigione» – Penna annota sempre la sua vicenda: è lui stesso un taccuino che legge senza spiegarcelo, in lampi di luce.
Amo Penna. L’ho sempre amato. Come Saba che gli scriveva: «Le tue poesie… io le amo così come sono; le amo… per lo più tutte». E aggiungeva: «Hai ragione di pensare che sei un poeta ed uno dei rari». La stessa gioia che dovette provare Penna da questa lettera, io la provai da una lettera inviatami da Sbarbaro. Avevo ventisette anni anch’io : «Quel che posso dirle – mi scriveva- è che tra i troppi libri di versi che ricevo e che scorro con infinita noia… il suo è uno dei pochissimi che conservo».
Mi piace vantarmi all’ombra di uno spirito come Penna, che a ventidue anni già confessava a un amico: «…Non amo più che pochi poeti… Ma l’amore per la Poesia imbeve tutta la mia anima e non mira alla, ahimè comune, mania letteraria».
E mi lega a lui la strana coincidenza che, ad una stessa età [ma io non lo conoscevo ancora], mi faceva cominciare la traduzione dell’opera omnia di Rimbaud e faceva dire a lui: «Rimbaud è ora divenuto realmente il mio Dio…»
E perché dovrei tacere il gusto di un’ “affinità elettiva”? Per umiltà? Per pudore? E perché? Elio Pecora riporta, nella sua bellissima postfazione a “Confuso sogno”, un appunto di Penna: «Perché mi sento l’anima farsi chiara e luminosa ora che vedo ragazzi semplici e sani, dalle gambe scoperte sotto il sole, intorno a una bicicletta che splende?» Non conoscevo ancora questo quadernetto quando dedicai a Comisso i seguenti miei versi «Se… un ciclista brilla dove piove,/ …se luglio/ si scheggia nel suo lampo-pedale/ …all’aria appoggiata si spoglia/ la bella freschezza poderosa/ brezza di qualcosa…»
La leggerezza. Ecco cosa spero di aver imparato da lui: che la poesia è la più scontrosa e leggera compagna di viaggio alla scoperta del mondo. «O leggero Penna» gli scriveva Saba, il 23 novembre del ’32, «O leggero Penna, tu non sai una cosa; non sai quanto t’ho invidiato…»
L’invidia. Ecco quello che sopra ogni cosa io provo per lui: l’invidia! Invidia per la sua disperazione luminosa, per l’angoscia profonda della poesia, per la sua anima sbigottita dall’innamoramento del mondo intero, per la sua voracità della vita, per la sua tragedia della bellezza, per la sua condizione di sogno confuso e magnifico…
Pecora scrive: «A diciassette anni Penna immagina una fine di bellezza: destino del poeta è testimoniare un sogno e in esso sparire». Sparire dunque, che vuol dire essere superflui. Penna è colpito dalla povertà di questo “superfluo”. E questo “superfluo” ch’egli produce ci appare un qualcosa di grandioso che stordisce. Ecco: “questo superfluo grandioso che stordisce”! altro non è che la poesia. E nel nostro caso, raro, la poesia di Penna.
Pasolini scriveva di lui: «Ne ho fatto un culto, e ho il rimorso di non essere così forte e così fedele da praticarlo degnamente». Si sa che i culti servono a chi li pratica, non agli altri. Bastava, caro Pasolini, amarlo! Ma né tu, né la Ginzburg, né la Morante che ne avevate fatto un mito, lo amavate. Gli hanno forse comprato almeno uno dei Rosai falsi che vendeva per campare? Non credo proprio. Io invece sì, pur facendoglielo notare. Sapete che mi rispose? «Certo che sono falsi, ma se tu credi che siano veri, sono veri». Mi fece capire che nella sua miseria tutto poteva essere vero. L’ho aiutato, ecco tutto, invece che incensarlo.
Gli italiani, diceva Lamartine, sono degli incorreggibili necrofili. Appena uno muore lo portano alle stelle, perché non dà più fastidio. Penna ha sfidato, come osserva Garboli, molte regole della poesia contemporanea. Ha rifiutato a suo rischio e pericolo la prassi dominante. Con il suo splendido artigianato spiazza d’un colpo l’edificio della lirica moderna.
Certo, Penna ha suscitato molte invidie, perciò ha avuto molto poco. Egli diceva chiaramente ciò che era e ciò che voleva. Non fingeva dietro simboli, come certi monumenti della nostra poesia. Per esempio, le tante promesse di Montale, poi inceppatesi, non erano che segrete rivalità. Anche il nostro Premio Nobel lo invidiava per il suo alto magistero formale, non certo per i suoi bisogni di amante del mondo. Lo stesso Saba, più sincero, gli scriveva: «Le tue poesie non mi sono piaciute per il loro contenuto, ma per la loro poesia!»
Ancora oggi, su di lui, molti poeti ufficiali fanno finta di niente. Si sentono disturbati dalla sua etica irregolare, dalla sua cosiddetta “orrenda condizione”, ma ne invidiano il mitico inarrivabile candore del linguaggio, questa eterna grecità che sterilizza, da Saffo in poi, ogni impurità linguistica.
Penna dice: «Ho capito che l’ispirazione è quella che conta: per me, il resto è meno, anzi non conta niente». La mia invidia per lui è ben diversa: io invidio la sua ispirazione, non ciò che lui scartava e che suscita l’invidia di quelli ch’egli chiamava “ i maniaci letterari”.
E a proposito di ispirazione, termine ora ridicolizzato, «La sessualità agisce su Penna» – spiega Garboli – «come una droga». Non mi pare. Una droga non permette il ragionamento. Infatti Penna in alcuni versi dice: «Il problema sessuale/ prende tutta la mia vita./ Sarà un bene, sarà un male… me lo chiedo ad ogni uscita».
E poi scrive: «So bene che troppo spesso non si vorrebbe scrivere nel momento in cui il senso è padrone di tutta la nostra persona». Eppure lo fa e sempre, in questi “momenti”. Io ho sempre creduto che la poesia fosse una forma di erezione sublimata. Penna non poteva fare altrimenti. Appunto come dice una quartina di un giovane poeta tedesco, Arnfrid Astel: «Poesia è affermazione di sé stessi/ in senso stretto erezione./ Qui sta ritta/ come un giovane arnese al mattino/ e non può fare altrimenti».
Ma Penna si riscatta, continua a promettersi il contatto poetico con la realtà, pur sentendo incessantemente «la morte nella vita». La morte. Lui la sente come un «fisico corposo sapore». Così scriveva a un amico il 10 Dicembre del ’31. «Fisico corposo sapore» ch’egli, il poeta che annega, trasferisce nella improvvisa vista sulla spiaggia di «un ragazzo al sole, nudo piegato sulle gambe, da cui esce la cosa giornaliera». Ecco: basta la vista di un bisogno fisico assoluto, che subito si salva dalla disperazione e si lega di nuovo alla vita con «dolorosa gioia».
Penna è questo: la tensione costante a una diversa realtà, che si traduce in un linguaggio sofferto della meraviglia. Come dice perfettamente Elio Pecora: «I suoi distici sono le folgoranti chimere di chi aspira a qualcosa che non gli toccherà».
Ed è in questa aspirazione totale, ma generica, che prende forma la sua confessione di fede spirituale sepolta per tutta la sua vita dalle vicende carnali. Un distico umile, purissimo, che fa piazza pulita di tanta retorica religiosa: «Dico Signore e poi non so cos’è / questa parola che pur amo tanto».

Nota del curatore
Ho ricevuto in dono da Gian Piero Bona questo testo inedito su Sandro Penna, scritto per una conferenza svoltasi a Roma alla fine degli anni Novanta e mai pubblicato prima, al fine di renderlo disponibile ai lettori, per lo meno in forma di articolo. Tengo a ringraziarlo con gratitudine a nome soprattutto della redazione di NC, con cui, speriamo, potrà ancora collaborare in futuro.
F. Occhetto