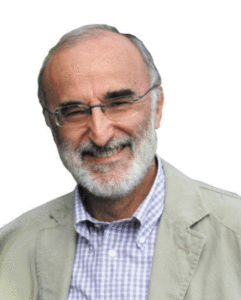
Eccola qua, eccola qua, incuneata nei miei passi più lenti e cautelosi, nelle giunture fredde, nei movimenti anchilosati, nelle artrosi.
M’interrogo. Da quando è incominciato? Da quando ho incominciato a sentirmi braccato dai sintomi del decadimento? Una risposta non la trovo.
Ho nel tempo accumulato gli avvisi, ma li ho trascurati, li ho omessi, ne ho scongiurato l’assedio con la disattenzione. Pessima strategia, perché mi trovo ora, qui, all’improvviso, a fare conti che non posso più eludere.
Forse non sono ancora pesantemente gravato da troppa zavorra, ma lei ha mandato segnali precisi, inequivocabili, che non posso continuare a ignorare, come ho fatto finora.
La vecchiaia, insomma, mi ha raggiunto. Mi ha inseguito a lungo, ma ora mi ha raggiunto. E allora comincio a sentire l’urgenza di parlarne, forse per allontanarne lo spettro, forse per accoglierlo meglio, forse per dissimulare la paura che ne ho, per depistare con la tattica dell’accoglienza il rischio dell’agguato proditorio, dell’aggressione improvvisa, devastante.
Tra i vecchi sono vissuto. Nel mondo della mia infanzia i vecchi erano parte attiva delle comunità allargate che erano le famiglie antiche. In campagna i vecchi svolgevano funzioni essenziali, erano la memoria dei campi e delle colture, a volte i depositari di saperi contraddetti fino al litigio, erano i conservatori dei beni e si opponevano sempre fervidamente a ogni pezzo di campo da vendere (se mai, vigilavano sui beni perché dai frutti nascessero nuove possibilità di acquisto e di espansione, la “roba”).
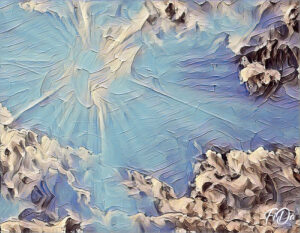
La terra, tuttavia, non era esclusivamente “possesso”, non soddisfaceva semplicemente l’avidità, ma era ambizione di ben fare, lavoro messo in vista, lungimiranza di investimento e di intelligenza strategica.
Non che mancassero le meschinità. Non che non si usassero malignità e astuzie. Ma a prevalere era quasi sempre – insieme con il vantaggio economico, che di certo non veniva sottovalutato – la soddisfazione di un’impresa che sollecitava nuove destrezze, nuove abilità. Vita da vivere, vita vissuta.
Il mio nonno materno non fui mai vecchio, perché morì giovane per il calcio di un cavallo. I miei nonni paterni non li ho conosciuti perché sono morti giovani per una tubercolosi letale. Io ho conosciuto solo la mia nonna materna e una mia prozia paterna, con le quali posso dire di avere visto la vecchiaia al lavoro.
Due diversissime vecchiaie, in verità. Perché alla vecchiaia placida e rasserenante della mia nonna faceva contrasto la vecchiaia acida e sterile della mia prozia, zia zitella del mio papà.
Alla vecchiaia ampia, larga, umilmente solenne e sedentaria di nonna Maddalena mal corrispondeva la vecchiaia secca, nodosa, occhiuta, di zia Anna, di cui – bambino – temevo lo sguardo grifagno, e nel migliore dei casi distante fino alla più perfetta indifferenza.
Mentre la nonna Maddalena era tutta dolcezza, zia Anna era tutta asperità. Mentre quella non pretendeva mai niente, questa comandava a bacchetta e puntava indici minacciosi.
Nonna Maddalena qualche volta tentava carezze che accoglievo, mentre la zia Anna non disdegnava di tentare qualche schiaffo che dovevo essere bravo a scansare.
Ma sia dell’una sia dell’altra non era il fatto che fossero vecchie la prima percezione. Tale era l’abitudine di stare con loro che non ne coglievo l’età. C’erano da sempre, ci sarebbero state per sempre. La loro vita era così congiunta alla mia che – come non sarei riuscito a vedere il finale della mia, ovviamente eterna – non mi riusciva di vedere il termine della loro.
Amavo nonna Maddalena e mi pareva di odiare la zia Anna. Ma dico “pareva” perché di fatto non l’ho odiata veramente mai. Venivano dei sacerdoti a farle visita e io entravo nel salotto buono per salutare (ero un bambino educato), anche se lei non diceva mai nulla che potesse valorizzare la mia presenza.
Mentre invece nonna Maddalena, che nessun sacerdote veniva a visitare, se non qualche volta – chiamato – per portarle la comunione in casa, visto che era ormai confinata nel suo letto o nel suo seggiolone, mi lodava ogni volta che poteva.
Qualche volta ho visto zia Anna mettersi in ghingheri e vestirsi da patronessa per le visite all’asilo (abiti neri, gonnelloni ampi e vellutati, corpetti ricamati di fino, scialli larghi e avvolgenti). Mai vista la nonna Maddalena con un vestito diverso dai forse non più di due che alternava: sempre rigorosamente scuri, un lutto mai dimesso.
Quanto quelle vecchiaie così diverse e a me così prossime possano costituire dei precedenti della mia vecchiaia più che incombente, non saprei dire. Posso, questo sì, dire: che a me piacerebbe vivere la mia vecchiaia secondo l’interpretazione – del carattere, della bontà – di nonna Maddalena.
Ma così non è. Io mi ribello, anche se so che è inutile e che – semplicemente – peggioro la situazione. Non sono un ribelle irriducibile, ma cerco lo stesso di allontanare il giorno dei conti.

Fare il nonno mi dà conforto, accudire la crescita delle creature che le mie figlie hanno partorito mi dà spesso gioia e qualche volta preoccupazioni, ma devo dire che quando sto lontano dai nipoti per un po’, a causa di qualche impegno che ancora mantengo, ne sento il bisogno e a volte – come ad esempio ieri sera, che mi sono affacciato al balcone e ho come inseguito la dolcezza di un tramonto sui tetti dei palazzi di fronte – avverto dentro di me come un sentimento radicale e assoluto: la percezione di una presenza che non mi prevede, ma che resta in qualche modo avvinta alla mia stessa esistenza.
Per tutto contrasto m’insegue il ricordo di un film che ho visto qualche anno fa al cinema. Un film di Haneke, intitolato Amour, e splendidamente interpretato da Trintignant e dalla Riva (da giovane fu attrice di Resnais in Hiroshima, mon amour), che credo abbia avuto una Palma d’oro a Cannes.
Due coniugi della buona borghesia parigina (lei maestra di piano, lui non si sa bene ma sicuramente legato a un’attività intellettuale) vedono sconvolta la loro vita dalla malattia degenerativa di lei, che lui assiste in casa fino all’epilogo tragico.
Un film che non concede nulla, non dirò ai “buoni sentimenti”, sempre ingannevoli, ma nemmeno a un soffio di speranza.
Tutto si muove con coerenza: una dignità gentile ma gelosa, un’affettività un po’ esclusiva, una figlia lontana e di fatto estranea (accolta come un’ospite), un riserbo che sa di esclusione.
Tutto si svolge nell’appartamento dei due coniugi, che diventa un set esemplare (porte aperte e chiuse, una vetrata da cui entra un piccione, che avrà una sua funzione narrativa, un pianerottolo che compare in un incubo di lui, un arredo calibratissimo e davvero evocativo).
Il senso profondo è quello dell’insopportabilità del dolore, della sua indecenza, della sua nudità, del suo squallore. Una meditazione sul deserto della morte piuttosto che sul mistero della vita. La vita che vale fino al momento in cui il corpo le consente di essere dignitosa. Non riscatto morale né respiro spirituale che tengano. Tutto cede nel momento in cui il corpo cede. E la morte diventa un gesto dovuto. Quello che lui – appunto – esegue.
E tuttavia resta il dubbio che procede da una riflessione sul film più di quanto venga di fatto dal film stesso, che mi pare prenda con chiarezza una direzione priva di ambiguità.
Per dare corso a questo dubbio (che cioè il gesto finale di lui sia un gesto di egoismo piuttosto che di amore) in me resta fermo un punto: in qualsiasi condizione, sotto qualsiasi frusta, sottoposto a qualsiasi privazione, l’uomo è portato a scegliere la vita rispetto alla morte.
Come nel dramma di Zweig, Jeremias: vivere, soltanto vivere, sentire ancora tra le dita un grano di sabbia del tempo. Detto da un suicida, a me pare che l’avviso valga enormemente di più, e che il suicidio suoni come la più drammatica istanza di un’antifrasi vitale.
Risposte non ne so dare, perché ho troppi dubbi che mi si accavallano. Ma quelle gambe di lei che fluttuano, nel film di Haneke, e che si tendono sotto le lenzuola al gesto di lui che la sta soffocando con il cuscino, mi sono rimaste impresse come volontà di vita, come una non arresa renitenza al morire.
Come faccio a dimenticare mio padre e mia madre? Tutt’e due, ormai anziani, che noi figli abbiamo – come si dice – messo in una casa di riposo con la scusa degli impegni, con il pretesto malamente consolatorio dell’assistenza migliore, tutto a difesa del nostro diritto alla vita.
A loro penso sempre più spesso. Penso a lui in preda a un tremito forse dovuto a una cattiva digestione, e a lei che chiede aiuto; lei – che gli sta perennemente seduta accanto al letto – agitata, e io che cerco di rassicurare lui e lei, ma soprattutto lui, andando a informarmi in infermeria, dove mi viene detto che più tardi passerebbe il medico.
Intanto il tremito diminuisce fino a cessare, ma l’agitazione resta palpabile. Lui continua a chiedere di cambiare posizione, continua a lamentare le ineguaglianze del materasso, continua a chiedere aiuto, mostra la legittima paura di chi avverte l’incombere della fine ma non sa né può interpretarne né i tempi né i modi.
Il medico – gentile – è poi passato e ha detto cose rassicuranti: che le analisi sono buone, che la febbre non c’è, che il balzo di pressione è rientrato, lasciando intendere che la vera malattia – in questo caso – è semplicemente quella dell’età. E che si tratta pertanto di viaggiare a vista, giorno dopo giorno.

C’è anche stato un momento in cui ho preso mio padre tra le braccia per dargli un po’ di sollievo ruotandone il corpo verso di me. Il piccolo corpo, rigido e nodoso come un tronco d’ulivo, il volto contratto e magrissimo, consunto ma severo, l’espressione cieca, la concentrazione stupita e allarmata nelle braccia dell’uomo forte e robusto che è stato, mi hanno fatto pensare che stavo compiendo i gesti di una deposizione.
M’è parso di provare l’infinito amore per un padre che non c’è già più, e di abbracciarlo come abbraccio ora i miei nipoti: la condizione infantile in cui quel corpo – un tempo così adulto – era ormai rientrato.
Nella notte c’è poi stata una spolverata di neve e quella neve ha coperto di bianco il trapasso di mio padre, che in quella notte stessa è morto.
Si affollano in me più pensieri: da un lato la comprensione di un movimento – quello della vita – che riduce la sua velocità e che costringe a fare passi meno precipitosi; dall’altro la consapevolezza del poco o nulla che sei, anche in rapporto alle ambizioni che hai avuto e alle presunzioni che hai nutrito; in mezzo l’idea che morire è essere cancellati: a cui – unica risorsa – queste mie riflessioni cercano di opporre il minimo di resistenza.
Da un lato ne traggo godimento ma dall’altro non so affatto se questo godimento sia disinteressato o non nasconda piuttosto i germi di una sottile propensione autodistruttiva. Di fatto l’idea della morte da cui veniamo sempre più spossessati in vista di paradisi promessi e di longevità da patriarchi biblici è un’idea che ci innerva e ci radica.
Perché, nonostante ogni avviso di omologazione, è la morte a renderci individuali e umani, non la vita. Si sposta “il paradigma”? Wittgenstein sostiene che non si può fare esperienza della morte? Nella sua spasmodica mania di esattezza razionalistica posso capirlo, ma resto in questo profondamente legato al pensiero di Heidegger: “essere nella morte”. O come dice qualcun altro: “In senso radicale, il morire è l’attestazione della fatticità esistenziale della nostra vita”. Anche se il termine “fatticità” è così neutro che lo considero un errore di traduzione.
Se a tutto ripenso, prima c’è stata l’ambizione di fare e di “esserci”, magari non proprio come Julien Sorel, ma certo con un forte desiderio di riscatto, di promozione, di possesso delle cose. Ora un allontanamento progressivo da tutto ciò che in altri tempi mi sarebbe parso indifferibile.
Vale a dire un programma di dimagrimento, che potrà apparire come una forma di diserzione, ma che a me suona come un necessario impegno a vivere il “sentimento della fine”.

E a questo proposito dovrei affrontare uno dei dati sensibili della mia “piccola” vita: quello dell’abbandono. A qualcuno è toccato patire nella vita che a tratti può essersi accompagnata alla mia le conseguenze di quello che io chiamo la “sindrome da abbandono”. Come a dire abbandonare per non essere abbandonati.
Ma si tratta di una lettura parziale. Vero che io ho abbandonato perché sono stato abbandonato o mi sono sentito abbandonato. Vero che la mia dimensione è sempre stata piuttosto individualistica e libertaria. Ma vero anche che ne ho accettato a mia volta le conseguenze e che questa pulsione è stata spesso bilanciata da un senso del dovere che nei momenti decisivi mi ha tenuto in carreggiata.
Mi domando a volte: dove la radice di tutto ciò? E mi dico: nell’infanzia, perché di fatto qualcosa di distintivo, e di gelosamente diverso, nella mia infanzia l’ho sempre profondamente percepito. Sapevo stare con gli altri, ma anche sempre avvertivo che qualcosa me ne distingueva.
Forse perché ero sempre affidato di qua e di là e forse questo ha fatto di me un nomade con il desiderio della fissa dimora. Ma anche il residente in preda a un suo sogno di lontananza.
Ho sempre sentito in me l’impulso a cercare qualcosa che appagasse il profondo desiderio di congiungermi alla mia parte perduta. E questo mi ha fatto commettere molti errori, mi ha indotto a provocare qualche infelicità ma – infine – anche a dare qualche gioia.
Il mio attuale assetto di rinuncia non ha nulla a che vedere con la diserzione. Ha invece a che vedere con il bisogno di alleggerimento: via la zavorra che ti tiene basso il volo, via le illusioni di un successo (effimero), via le presunzioni di una solidità studiosa capace di procurare all’umanità un’opera più duratura del bronzo, via i pensieri meschini.
Non disprezzo chi ci crede e sente il dovere di restare ancorato a un impegno cui tiene fede in nome dei propri principi e del proprio sentire, ma confido nella comprensione di chi – aderendo a una diversa visione – sappia accettare la necessità della mia.
Uscito per una passeggiata, oggi ho osservato una ragazza che camminava davanti a me e che aveva un portamento altero e insieme flessuoso e ho pensato a un racconto: L’enigma della ragazza che cammina davanti a me ovvero La forza del mattino.
E subito dopo ho pensato: noi siamo nella morte perché il grande enigma è quello. La vita è inafferrabile, irriducibile a un ordine che non sia una forma mentale, una semplice operazione di metodo. Perché le discipline scientifiche possono chiudere? Perché si riducono a un “metodo”, stringono il campo, pretendono una risoluzione (i problemi si “risolvono”, sono-per-essere-risolti).
La stessa differenza che passa tra enigma ed enigmistica. L’enigmistica stringe in risposta ciò che l’enigma pone sempre in termini di domanda.
Mentre la letteratura è “senza fondo” perché mette in scacco ogni presunzione di certezza. Morire perché vivere è sempre inadeguatezza, sempre “rettorica”.
La lista è orizzontale così come è orizzontale la vita (si presta all’elenco, alla sua vertigine, non all’esaurimento). Discendere nella fossa dei misteri. Disperdere le proprie ceneri nel vento: due i modi di dire, uguale il senso. Magnifica la definizione di Kraus: “La scienza è analisi spettrale. L’arte è fotosintesi”.
Così sento a volte la tristezza, non solo della carne, ma della cultura. Della cultura collosa, della cultura ingegnosa, della cultura ingenerosa, della cultura fastidiosa, della cultura esibizionistica, quella stessa a cui a volte mi sono concesso; della cultura nominalistica, della cultura disonesta.
Quanta cultura apparente fa velo e paravento al soffio più o meno evidente dell’inconsistenza, dell’insipienza, dell’impudenza, del nulla? Quante parole sparse a piene mani per colmare il vuoto. Gettate al vento per ingravidare il mostro della chiacchiera. Sento bene – e spesso – questo soffio infinito della vanitas.
Nulla – davvero – sembra a tratti degno di considerazione, specie se penso a chi non possiede strumenti di interpretazione troppo sofisticati, e così spesso sofistici.
Quale è mai la vita di chi “non legge”, di chi “non sa”, di chi “non si cura”? Forse più degradante? Forse più degradata? Come può accadere che proprio lì fiorisca il profumo delle virtù più umili e quotidiane?
Torno a pensare alla mia nonna mitissima, a mio padre che andava a cogliere la camomilla nei prati, alla pacatezza con cui i contadini della mia infanzia se la chiacchieravano sul sagrato, prima della messa, o in piazza, davanti alla ruota del mulino. Parole che aderivano alla cosa. Poche e definitive. Magari qualche variazione spiritosa e qualche grossolanità spessa.
Ma sempre una misura di compostezza e di ruvidità. Io ho sempre sognato di andarmene via di lì, perché avevo qualche sogno e qualche ambizione, ma capivo d’istinto – pur non volendo enfatizzare, e soprattutto estetizzare nulla – che dietro quegli uomini a cui pure niente pareva legarmi, c’era una ritualità: un galateo non scritto ma ottemperato nei fatti, nei gesti. Ci poteva essere dell’avarizia, sicuramente della grettezza. Ma mai sordidezza.
Tutto funzionava secondo ritmi non scritti, ma tramandati. Pause (anche lunghe), come se il pensiero andasse prima rimuginato e riflettuto. Non era di sicuro un salotto borghese, fatto di guizzi, scatti, motti, parole eleganti e astuzie discorsive. C’era chi sapeva metterci il suo sale, ma l’argomentare era tutto sodo e quadrato.
Domani è Natale, siamo a Natale, i miei ottanta natali.
Avverto qualcosa che sta sospeso, c’è qualcosa che comincia a muoversi, ma pigramente, sottopelle. Qualcosa che prende coscienza a poco a poco, ma centellina il momento che precede il movimento. Qualcosa di nativo, di sorgivo, di inespresso, di potenzialmente infinito, di enorme: speranze che insorgono, desideri che formicolano, sicurezze che si snodano e che rendono possibile tutto.
È la tregua, il senso della tregua, e si presenta come un’aurora, un interstizio, un momento di transizione, di passaggio. Lì si rintanano le ore, mettono lì le loro radici, che poi accestiscono (un verbo che sento così tanto pascoliano…) e che poi – consumate – appassiscono con il passare dei momenti, uno dopo l’altro.
Ma lì si conserva il segreto della vita, il suo fiorire continuo, il suo proporsi ostinato, il suo dono. Lì cogliamo l’essenza della nostra vita che si consuma, lì l’energia festiva dell’infanzia rinnovata, la fiducia ingenua nelle nostre potenzialità intatte o rigenerate.
Se penso alla Tregua di Primo Levi, penso a uno dei libri che meglio hanno espresso questo sentimento della vita che scaturisce dalla morte che l’ha preceduta, anche se già contiene la consapevolezza della morte che verrà e che tornerà a incombere coi suoi mostri nefandi.
Noi sappiamo che il mattino è pieno di promesse e si offre a noi con ineluttabile puntualità. E noi lì a farcene ingannare, consapevoli e nello stesso tempo magnificamente ottusi, impegnati a gustarne i sentori, a coglierne i sentimenti, sapendo che poi il giorno ci tradirà.
E allora mi metto alla scrivania e scrivo: mattino che salti dalle nuvole sui tetti, mattino che sgusci nelle strade, mattino che avvolgi nel silenzio il risveglio delle cose, mattino che accarezzi le ombre e le consoli, che inondi le sporgenze dei balconi, che t’arrampichi fino alle cimase, mattino che entri nelle chiese e che scali le pareti dei tinelli, delle cucine, delle stanze, dei cancelli, mattino che entri nelle scarpe e le fai camminare con la gioia che non dura, ma intanto c’è, mattino che procuri un brandello di speranza e la metti dove frigge per un po’, mattino che svegli i miei nipoti dal sonno delle tenebre che li hanno ottenebrati, mattino dei sommersi e dei salvati, mattino che certifica il nostro esserci nel mondo, mattino del mio girotondo, mattino del mio cuore che batte nei suoi ottant’anni, mattino delle mie ciabatte che salpano leggere dalla camera da letto alla cucina, dove cerco di farmi un caffè.
A mio modo canto, come posso, perché non ho mai avuto se non voce stonata.
All’improvviso mi viene a fare visita il ricordo di un curendero peruviano che mi profetò tanta vita in ragione del fatto che – così mi disse – tu sei un uomo buono. Io so che non è vero, so bene che sono un uomo come tutti, con le bassezze di tutti e con le difettività comuni. Ma resto a quella profezia, abbarbicato come l’edera al fusto di una pianta secolare.
La vita, soprattutto e sempre la vita, in me, a dispetto di questo corpo che recalcitra, di questi miei passi impacciati, di questi colpi che prendo negli spigoli delle porte e che mi lasciano visibili ematomi, alle gambe, alle braccia.
Cerco di resistere così, non facendo nulla. Sosto a lungo alla scrivania, mi do alla gioia dello scrivere, non cerco altro, e vedo di trarre dalle parole che scrivo l’ultimo succo di una vita che continuo a vivere. Anche so che questo non è che il racconto di me, il racconto dei miei pensieri ultimi, la favola di quelle cose con cui cerco di fare i conti, senza riuscirci interamente.

La verità più profonda che so dire – e so bene di quanto patetico sia dotata questa “mia” verità – è che vorrei inoltrarmi nel bosco interamente pacificato. Con tutto e con tutti. Vorrei entrare nel fitto con la leggerezza del passero, vorrei seguire il piccolo filo di luce che passa nel buio e che mi indirizza la strada. Vorrei portare con me il meglio di me, la consapevolezza di non avere vissuto invano, con qualche vantaggio degli altri, a cui possa avere dato qualche barlume del più gioioso me.
So, invece, che mi restano dentro residui di rimpianto, quantunque faccia di tutto per non stare a sentire. Avrei potuto fare altro? Fare diversamente? Di certo sì, ma anche così mi sarei dovuto portare dietro, in ogni caso, un’altra zavorra.
Vivendo l’ultimo tratto della mia leggenda, mi preparo a entrare nel mio bosco, confidando in una misericordia che non dico. Non ho certezze, ma ho speranza. Confido nell’abbraccio e attendo che l’accoglienza vinca sul giudizio che meriterei. Mi preparo a entrare nel cuore della mia ghianda, nel destino per cui sono vissuto e (ancora) vivo, nella vita che per sempre mi piacerebbe vivere.
