Io affermo che tu esisti nel tempo
mia metafora, mia affannata ripetizion
di sagoma o di volto che dai libri
discendi ma non dal cielo che io contemplo.
Svelami una luce più viva dell’inchios
che sulla pagina persiste come un vizio
o una incarnata domanda…
(Guido Garufi)
 Considero un grande privilegio, accompagnato da un imbarazzo ineludibile, chiudere in un certo senso il cerchio dei miei articoli su alcuni poeti fondamentali del Secondo Novecento, con alcuni cenni sulla figura di Guido Garufi. Ricordo infatti che il mio primo intervento su Nuova Ciminiera era dedicato allo splendido saggio su Sereni che costituiva in pratica la tesi di laurea di Remo Pagnanelli (La ripetizione dell’esistere). Concentrandomi ora sull’altro dei “dioscuri”, come li definiva Mario Luzi, un cerchio si chiude. Ma probabilmente, valutando il mio umile apporto alla versione online di una gloriosa e per me mitica rivista, nel bilancio di questa breve ricapitolazione su alcune voci di assoluto rilievo, la voce di Garufi non può mancare per altezza lirica, acume critico e per la posizione fondamentale della sua scrittura. Ancor di più in questo caso sarà indispensabile riflettere sulla portata dei maestri del Novecento e della tradizione lirica europea, a quella venerazione per la biblioteca che in Garufi è riuscita sempre a non tradursi in erudizione esangue. Proprio nel bellissimo Filigrane, “il cuore messo a nudo” del poeta e critico maceratese, una serie di prose liriche e di ricordi personali (non privi, spesso, d’ironia), negli immediati dintorni della sua poesia; proprio nel suo ultimo libro Garufi ha ammesso che nulla più della voce dei poeti amati gli ha permesso di trasformare la propria vita da sopravvivenza ad esistenza. Ci si voglia soffermare sul peso specifico delle parole dell’autore senza scomodare la ricorrente conclusione di una poesia che “salva la vita”. Nessuno dei poeti su cui ho scritto la condividerebbe, e questo vale anche per il maceratese: “Ben oltre questo libro è la tua vita”, afferma nell’ultima raccolta, Fratelli. O ancora in Filigrane: “non appartengo a quella troppo folta schiera di narcisi o mistico-ossessivi che identificano la letteratura con la vita. Per me le due cose non convergono, semmai, a volte, esiste un parallelismo. E troppi ne ho conosciuti che pensavano o ritenevano che il loro testo fosse “tutto”…è un grande errore. La poesia è stata, ed è per me, unicamente un approfondimento dell’anima, una lente per leggere meglio le cose, quelle personali e quelle degli altri. Da questa mia “dottrina introspettiva”, vorrei provvisoriamente chiamarla così, nasce l’ipotesi (sperimentata) che l’incontro con l’altro, se nutrito di tale retroterra emotivo, sia un vero e proprio atto “magico”, simile a quello del Vecchio marinaio della insuperabile ballata di Coleridge. Strane intuizioni, piccole folgorazioni, incontri improvvisi, questi e solo questi sono i segnali di tale fenomenologia”. Un estratto di un brano che ha per titolo Intermittenze e claustrofilia, due parole molto care al Nostro. In particolare Garufi riconosce alla lingua poetica la facoltà rabdomantica di cogliere quei “lapilli di luce” e quelle “interferenze” misteriose, occulte, ignote soprattutto a chi, per dirla con Montale, “crede che la realtà sia quella che si vede”.
Considero un grande privilegio, accompagnato da un imbarazzo ineludibile, chiudere in un certo senso il cerchio dei miei articoli su alcuni poeti fondamentali del Secondo Novecento, con alcuni cenni sulla figura di Guido Garufi. Ricordo infatti che il mio primo intervento su Nuova Ciminiera era dedicato allo splendido saggio su Sereni che costituiva in pratica la tesi di laurea di Remo Pagnanelli (La ripetizione dell’esistere). Concentrandomi ora sull’altro dei “dioscuri”, come li definiva Mario Luzi, un cerchio si chiude. Ma probabilmente, valutando il mio umile apporto alla versione online di una gloriosa e per me mitica rivista, nel bilancio di questa breve ricapitolazione su alcune voci di assoluto rilievo, la voce di Garufi non può mancare per altezza lirica, acume critico e per la posizione fondamentale della sua scrittura. Ancor di più in questo caso sarà indispensabile riflettere sulla portata dei maestri del Novecento e della tradizione lirica europea, a quella venerazione per la biblioteca che in Garufi è riuscita sempre a non tradursi in erudizione esangue. Proprio nel bellissimo Filigrane, “il cuore messo a nudo” del poeta e critico maceratese, una serie di prose liriche e di ricordi personali (non privi, spesso, d’ironia), negli immediati dintorni della sua poesia; proprio nel suo ultimo libro Garufi ha ammesso che nulla più della voce dei poeti amati gli ha permesso di trasformare la propria vita da sopravvivenza ad esistenza. Ci si voglia soffermare sul peso specifico delle parole dell’autore senza scomodare la ricorrente conclusione di una poesia che “salva la vita”. Nessuno dei poeti su cui ho scritto la condividerebbe, e questo vale anche per il maceratese: “Ben oltre questo libro è la tua vita”, afferma nell’ultima raccolta, Fratelli. O ancora in Filigrane: “non appartengo a quella troppo folta schiera di narcisi o mistico-ossessivi che identificano la letteratura con la vita. Per me le due cose non convergono, semmai, a volte, esiste un parallelismo. E troppi ne ho conosciuti che pensavano o ritenevano che il loro testo fosse “tutto”…è un grande errore. La poesia è stata, ed è per me, unicamente un approfondimento dell’anima, una lente per leggere meglio le cose, quelle personali e quelle degli altri. Da questa mia “dottrina introspettiva”, vorrei provvisoriamente chiamarla così, nasce l’ipotesi (sperimentata) che l’incontro con l’altro, se nutrito di tale retroterra emotivo, sia un vero e proprio atto “magico”, simile a quello del Vecchio marinaio della insuperabile ballata di Coleridge. Strane intuizioni, piccole folgorazioni, incontri improvvisi, questi e solo questi sono i segnali di tale fenomenologia”. Un estratto di un brano che ha per titolo Intermittenze e claustrofilia, due parole molto care al Nostro. In particolare Garufi riconosce alla lingua poetica la facoltà rabdomantica di cogliere quei “lapilli di luce” e quelle “interferenze” misteriose, occulte, ignote soprattutto a chi, per dirla con Montale, “crede che la realtà sia quella che si vede”.
Vorrei soffermarmi, poi, sulla particolarità di una posizione che, in quanto erede, figlio anch’esso come Benzoni e Pagnanelli, di Sereni, conservi una concezione molto elevata della letteratura proprio nell’apparente diminuzione della stessa; proprio, cioè, nel punto doloroso in cui lo scriba riconosce l’insufficienza della parola a dire la vita. Permane peraltro, a livello di caratterizzazione psicologica, ma anche etico-estetica, una virilità di fondo, dal forte sapore leopardiano, in quella che in Filigrane il maceratese definisce la sua malinconia attiva, propositiva; le sue tendenze claustrofiliche non prendono mai la deriva dell’angoscia. Il rapporto d’amore-odio con Macerata, l’amarezza personale e storica verso un ambiente che avverte spesso come stantio, non gli impediscono di ribadire la propria fedeltà al valore anche pedagogico della letteratura e, prendendo a prestito dal linguaggio alchemico, di “mettere a cuocere” le parole dei poeti amati nelle conversazioni con quelli che Pagnanelli chiamava gli “inevitabili”, i frequentatori abituali entro le mura cittadine.

Concezione molto elevata della letteratura, dicevamo: è proprio grazie alla filigrana del ricordo e della letteratura che avviene la rivivificazione del poeta, il miracolo montaliano. Memore di nuovo della lezione dell’irrinunciabile Leopardi (anche ciò che fu doloroso acquista, nel ricordo, una sua dolcezza e levità), dell’amato Pascoli (“il ricordo è poesia e la poesia non è, se non ricordo”), per il quale l’acutissimo studioso rinvenì proprio l’assenza totale del verbo futuro nelle Myricae, Garufi fa della filigrana della memoria e della biblioteca il suo “cannocchiale rovesciato”, il caleidoscopio di una “vita al quadrato” (Luzi). Solo raramente, in poesia, si era abbandonato ad un’ironia sarcastica (forse nella sezione Poesie del disamore in Fratelli) ma dal fondo amaro, soprattutto sulla meschinità delle logiche dell’università italiana. Irresistibili le sue staffilate, nella raccolta di prose, dall’alto delle sue previsioni magiche, oracolari, sull’assegnazione delle cattedre universitarie.
Altrove in Filigrane l’ironia è più dolce, distesa, ma non priva sia di elementi umoristici, sia, in fondo, di rilievi significativi, soprattutto sul rapporto con la psicanalisi che s’intreccia con gli amori e l’ascolto paziente delle compagne di viaggio. Lo si dica perché anche sulla psicanalisi la posizione di Garufi è stata sempre molto netta: troppo spesso il filtro letterario per restare ingabbiato nella rete psicanalitica, che per Garufi ha sempre costituito un depotenziamento della parola poetica (ricordo anche le sue riserve su Atelier d’inverno dell’amico fraterno Pagnanelli, raccolta a suo parere troppo influenzata dal ricorso alla psicanalisi). E su un altro punto bisogna essere molto chiari: la pagina piena, densa, luziana di Garufi, rifugge ogni tipo di décor surrealista; la sua produzione in fondo parca non ha nulla della fluvialità di un Eluard, per fare il nome di un protagonista del Novecento avversato da Montale proprio per la presa di distanza del genovese da Surrealismo e psicanalisi. In un saggio poi raccolto nel volume Fenomenologia di Montale, Garufi implicitamente rispondeva alla tesi della studiosa Giusi Baldissone (Il male di scrivere. L’inconscio di Montale, Einaudi, 1979), dando un’interpretazione della poesia Un sogno uno dei tanti (dal Quaderno dei quattro anni) che apre la poesia di Montale più al versante junghiano o di Hillman, seguace dello stesso Jung; Garufi ribadisce cioè il carattere “magico” della poesia del maestro e ritiene assolutamente inadeguata la griglia psicanalitica in cui lo vede costretto. Lo stesso dicasi per la valenza ampia, magica della notte (cfr. Fratelli e Filigrane): se inizialmente il Nostro aveva provato a correlarla alla notte dell’inconscio, aveva poi dovuto rifuggire dalla tecnicalità psicanalitica, dal suo sterile tentativo di svelare quella fascinazione. Molto più suggestivo invece indugiare sulla quiete leopardiana (“Dolce e chiara è la notte e senza vento”) e montaliana, quell’immobilità metafisica dove può schiudersi una verità, un lampo, il miracolo del poeta genovese, l’aprirsi di un varco. In un certo senso la notte diviene anche la dimensione privilegiata della poesia nel doppio significato di “rivelare”, svelare nel silenzio notturno, ma anche velare una seconda volta, occultare.
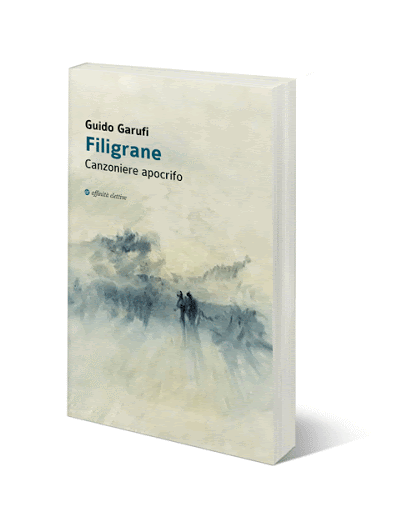 Ma tornando alla filigrana del ricordo, e qui la vicinanza a Sereni e Pagnanelli si fa ancora più stretta, essa è anche la chiave attraverso cui, poeticamente, gli assenti convivono con l’autore; la poesia diviene anzi luogo d’elezione di un dialogo che non si è mai davvero interrotto. E non serve scomodare nessuna visione mistica, spiritualista, metafisica; anzi in questo Garufi si mantiene un classico che non intende incendiare le leopardiane illusioni. Ha notato Enrico Capodaglio come nella sua ultima raccolta Fratelli non sia mai presente la parola “fede”; predominante invece la parola “fedeltà” appunto nella direzione centripeta della stesura di un unico libro, e direzione centrifuga della costellazione degli affetti e dei maestri, senza svolte annunciate, “gridate”. Se penso ai due ultimi poeti di cui mi sono occupato, tra la poesia impastata di vita di Piersanti e la propensione musicale di Davoli, la lirica di Garufi si distingue per essere la poesia più colta, estremamente fitta di citazioni, sebbene questa attitudine non si traduca mai in un citazionismo sterile, automatico. Mi si permetta di ricordare una discussione a voce proprio tra Piersanti e Garufi sull’elemento decisivo nella formazione del giovane Leopardi: se l’urbinate propendeva a riconoscere nel paesaggio, nelle colline “classiche” di Recanati, la fonte dell’idillio; il Nostro vedeva un tramite decisivo della sua genialità nella sconfinata biblioteca del padre Monaldo. Tuttavia l’archetipo della biblioteca non deve mai far pensare ad un gioco fine a sé stesso: Garufi sa affidare all’energia evocativa della parola la testimonianza accesa di uno scriba in connessione simultanea con gli scribi del passato e del presente. Evidente l’incardinamento affettivo dei suoi versi e delle Filigrane, una prossimità con i propri cari e con gli autori che legge ed ispeziona da una vita, senza che poi il testo possa racchiudere tutto, divenendo invece una lente attraverso la quale passato e presente possano convivere senza steccati che li dividano con nettezza.
Ma tornando alla filigrana del ricordo, e qui la vicinanza a Sereni e Pagnanelli si fa ancora più stretta, essa è anche la chiave attraverso cui, poeticamente, gli assenti convivono con l’autore; la poesia diviene anzi luogo d’elezione di un dialogo che non si è mai davvero interrotto. E non serve scomodare nessuna visione mistica, spiritualista, metafisica; anzi in questo Garufi si mantiene un classico che non intende incendiare le leopardiane illusioni. Ha notato Enrico Capodaglio come nella sua ultima raccolta Fratelli non sia mai presente la parola “fede”; predominante invece la parola “fedeltà” appunto nella direzione centripeta della stesura di un unico libro, e direzione centrifuga della costellazione degli affetti e dei maestri, senza svolte annunciate, “gridate”. Se penso ai due ultimi poeti di cui mi sono occupato, tra la poesia impastata di vita di Piersanti e la propensione musicale di Davoli, la lirica di Garufi si distingue per essere la poesia più colta, estremamente fitta di citazioni, sebbene questa attitudine non si traduca mai in un citazionismo sterile, automatico. Mi si permetta di ricordare una discussione a voce proprio tra Piersanti e Garufi sull’elemento decisivo nella formazione del giovane Leopardi: se l’urbinate propendeva a riconoscere nel paesaggio, nelle colline “classiche” di Recanati, la fonte dell’idillio; il Nostro vedeva un tramite decisivo della sua genialità nella sconfinata biblioteca del padre Monaldo. Tuttavia l’archetipo della biblioteca non deve mai far pensare ad un gioco fine a sé stesso: Garufi sa affidare all’energia evocativa della parola la testimonianza accesa di uno scriba in connessione simultanea con gli scribi del passato e del presente. Evidente l’incardinamento affettivo dei suoi versi e delle Filigrane, una prossimità con i propri cari e con gli autori che legge ed ispeziona da una vita, senza che poi il testo possa racchiudere tutto, divenendo invece una lente attraverso la quale passato e presente possano convivere senza steccati che li dividano con nettezza.
Tra i maestri che il maceratese convoca sulla “neve/uniforme del ricordo” (Luzi), il primo è proprio Luzi, alla cui pronuncia e alla pagina sempre molto stipata degli alessandrini, Garufi fa da sempre riferimento, così come a una rotondità e classicità del verso che attinge fin dal Primo Ermetismo; Garufi rileva quella dimensione colloquiale del secondo Luzi, quello di Nel magma, passando per le atmosfere familiari e intimiste di Dal fondo delle campagne, vero e proprio livre de chevet del Nostro. Dallo sperimentalismo dialogico dei maestri della Terza generazione (il Sereni de Gli strumenti umani, naturalmente) il maceratese eleva il proprio canto tra i sodali, i vivi e gli assenti, quanto mai presenti in un colloquio che la morte ha solo cambiato. La poesia di Garufi sembra voler cogliere nell’ascolto del vento (Leopardi) e del mare (La spiaggia di Sereni), le voci dei trapassati che passati non furono, nonostante il dolore che procura la separazione imposta dalla morte. Affinato nel laminatoio del dolore, oltre ogni mitologia grandiosa, come ben riflette la sua Musa domestica, il maceratese convoca nella dolcezza del ricordo e nella semplicità di un paesaggio familiare e classico, i maestri-poeti scomparsi e gli amici (Pagnanelli su tutti). A proposito, poi, della cantabilità e memorabilità del verso, all’equilibrio nell’affrontare la pagina in fondo classico, non bisogna dimenticare come, in una prospettiva spirituale, ma laica, lo scriba di Garufi presieda a una conservazione del senso, a quella funzione “archeologica” che Pagnanelli aveva limpidamente teorizzato in Punti per un’improbabile etica poetica: ”La poesia è per me operazione archeologica, nella duplice direzione di discorso del Principio e conservazione e custodia di ciò che è andato perduto o che si sta perdendo, di ciò che comunque il nostro cervello antichissimo vede di continuo “riaffiorare”. Nell’esistenza catacombale che si presenta al nostro ‘mandato’ rifiutato dalla società del rumore, il poeta è il custode non solo del linguaggio quale patrimonio della specie e della Memoria, ma il custode di quel museo che raccoglie i reperti (per tramandarli) della Natura…”.
Mi sembra inoltre che il Nostro non rinunci mai davvero all’eleganza del verso e al preziosismo stilistico di cui aveva dato prova fin dal folgorante esordio di Hortus (1981), attingendo con sorprendente varietà soprattutto dagli inglesi (Keats e Coleridge su tutti) o da Eliot, con dovizia di citazioni, nonché dallo sterminato bagaglio della poesia italiana, che da sempre ha saputo interpretare con rigore filologico anche nella sua attività di critico. Ineguagliabile la sua antologia su La Poesia delle Marche – Il Novecento, del 1998, aggiornata nel dicembre 2021 con La Poesia delle Marche. Il Novecento e oltre, la cui completezza mi fa davvero pensare che il maceratese abbia compiuto, in proporzione, ciò che Pier Vincenzo Mengaldo ha fatto per l’Italia con il suo Poeti italiani del Novecento. Lo si dica, dunque, per l’acume e la vastità dell’antologia-museo in divenire, ma anche per ciò che Mengaldo ha sempre riconosciuto e rivendicato, per il critico, come ha ripetuto recentemente parlando dei suoi scritti su Fortini. In una conversazione con Massimo Raffaeli che lo incalzava sul debito della sua scrittura critica verso Fortini, Mengaldo ricordava che in fondo Fortini non era il “suo” poeta. I “suoi” poeti, i prediletti, restano Leopardi, Montale, Sereni. Ma il vero critico deve saper “maneggiare” anche la materia che non gli è propriamente affine. Come non rapportare a una simile visione la lucidità del nostro “scriba”, poeta-critico, scrittore degli scrittori, che ha saputo attraversare con disinvoltura lo sperimentalismo di un Ferretti o Di Ruscio; il canto mimetico-impressionista, legato alla tradizione, di Piersanti; l’essenzialità simbolica e verticale di Scarabicchi; il “rigore insanguinato” di Pagnanelli, solo per citare alcuni protagonisti della regione italiana poeticamente tra le più composite e ricche. Inoltre, lo aveva già rilevato Carlo Bo, se per ogni regione italiana fosse stato compiuto lo sforzo filologico espresso da Garufi, oggi avremmo un quadro molto più veritiero dei valori poetici e delle reali forze in campo, depurate dalle sirene dei grandi poteri editoriali e dalle fanfare di conventicole generazionali. Raramente, come in Pagnanelli e Garufi, il rigore critico ha assunto la forza di un vero e proprio metodo per riconoscere una parola carica di senso, in grado di prendere di peso la vita e la morte.
Ineguagliabile la sua antologia su La Poesia delle Marche – Il Novecento, del 1998, aggiornata nel dicembre 2021 con La Poesia delle Marche. Il Novecento e oltre, la cui completezza mi fa davvero pensare che il maceratese abbia compiuto, in proporzione, ciò che Pier Vincenzo Mengaldo ha fatto per l’Italia con il suo Poeti italiani del Novecento. Lo si dica, dunque, per l’acume e la vastità dell’antologia-museo in divenire, ma anche per ciò che Mengaldo ha sempre riconosciuto e rivendicato, per il critico, come ha ripetuto recentemente parlando dei suoi scritti su Fortini. In una conversazione con Massimo Raffaeli che lo incalzava sul debito della sua scrittura critica verso Fortini, Mengaldo ricordava che in fondo Fortini non era il “suo” poeta. I “suoi” poeti, i prediletti, restano Leopardi, Montale, Sereni. Ma il vero critico deve saper “maneggiare” anche la materia che non gli è propriamente affine. Come non rapportare a una simile visione la lucidità del nostro “scriba”, poeta-critico, scrittore degli scrittori, che ha saputo attraversare con disinvoltura lo sperimentalismo di un Ferretti o Di Ruscio; il canto mimetico-impressionista, legato alla tradizione, di Piersanti; l’essenzialità simbolica e verticale di Scarabicchi; il “rigore insanguinato” di Pagnanelli, solo per citare alcuni protagonisti della regione italiana poeticamente tra le più composite e ricche. Inoltre, lo aveva già rilevato Carlo Bo, se per ogni regione italiana fosse stato compiuto lo sforzo filologico espresso da Garufi, oggi avremmo un quadro molto più veritiero dei valori poetici e delle reali forze in campo, depurate dalle sirene dei grandi poteri editoriali e dalle fanfare di conventicole generazionali. Raramente, come in Pagnanelli e Garufi, il rigore critico ha assunto la forza di un vero e proprio metodo per riconoscere una parola carica di senso, in grado di prendere di peso la vita e la morte.
Al vastissimo bagaglio di letture del Nostro fa da contrappunto, sul piano poetico, un’insolita compattezza stilistica tra le varie raccolte (dall’esordio con Hortus, come detto, nel 1981; all’ultimo libro di versi, Fratelli, 2016) già notata da Giovanni Tesio in postfazione; insolita in tempi di dissolvimento delle poetiche come quelli che viviamo. In nessun libro del maceratese è possibile cogliere un vero momento di rottura, fedele da sempre, il poeta, al precetto di Borges che “ogni autore è autore di un solo libro”. In un percorso a cavallo dei due secoli che lo ha visto autore di una produzione poetica parca (non più di 5 raccolte, che comprendono, oltre alle due sopracitate, Conversazione presunta, 1989; Canzoniere minore, 1997; Lo scriba e l’angelo, 2003), ma sicurissima, Garufi ha pazientemente delineato i tratti di uno “scriba provinciale” (Tesio), nella sola accezione di scrittore appartato, lontano dai grandi circuiti editoriali (Roma e Milano); uno scriba di cui il maceratese ha fatto un vero e proprio archetipo, in quanto custode, responsabile (di qui l’irrinunciabile afflato etico) nel tramandare una tradizione, un sapere. In fondo nessun autore su cui ho scritto nasconde la sua appartenenza a una tradizione ben precisa, di contro alla moda imperante della ricerca ossessiva di “originalità”. In questo senso nessuno più di Garufi esibisce con orgoglio il filo di fedeltà che lo lega ai maestri. Un legame con la tradizione che investe sia la critica feroce ai giornali (la sezione Poesie del disamore in Fratelli), al cattivo gusto, sia la critica alla superficialità del Web, come ho potuto constatare nelle mie conversazioni con il poeta che dimostra di possedere anche un retroterra sociologico di tutto rispetto (da Franco Ferrarotti al neurofisiologo Manfred Spitzer). Un canto che si eleva a difesa della “vita offesa/dal Dominio”. L’attacco alla modernità per il Nostro riguarda la scrittura stessa: l’architettura del testo può sorgere solo da una scrittura grafica; la tastiera del computer, parole dell’autore, “è per i geometri”.

Andando oltre il carattere anche aneddotico di questi rilievi, la presenza dei grandi maestri del passato è ancora attestata dai frequenti leopardismi (“notturna lampa”, “quanto ancora duri quaggiù l’affanno”, “Volgono al termine le luci della sera”) che tuttavia non si traducono unicamente in sterile arcaismo o residui di una tradizione da preservare, ma sono il tessuto di un’invocazione civile alla resistenza, a quell’affratellamento tra gli uomini a cui esortava lo stesso Leopardi de La ginestra:
E’ l’acqua quella che riscatta la vita offesa
dal Dominio e dalla quale ancora parte
questo canto come una ginestra
che non piega il suo capo
ma il suo colore irradia oltre ogni colle
frontiera o no nel ganglio oscuro e luminoso.
Per tutta la produzione di Garufi potremmo forse cogliere una doppia direzione, anch’essa centripeta e centrifuga, rispetto alla circolarità del testo: da una parte la fissità, immobilità che fanno della frontiera del testo, della perfezione del cerchio, un reticolato protettivo di certezze (“perfetto il cerchio”, in Conversazione presunta, è una diretta citazione del Diario d’Algeria di Sereni), delle conferme all’ipotesi psicanalitica dello stile e della pagina come barriera, difesa rispetto alle irruzioni della vita (Pagnanelli); dall’altra il rischio dello stile come prigione, ma allo stesso tempo chiave d’uscita dal labirinto (Borges), rottura dell’assedio (anche in Filigrane rappresentato dal cerchio delle mura di Macerata; ma da sempre metafora ossessiva delle Marche e della città amata/odiata, allegoria che trova la sua origine psicologica precisa nella paura della ripetitività dell’esistere, che provoca angoscia e ossessione):
E calibro il pensiero alla ricerca di un tratturo
non di una via maestra, di un vicolo, di un pertugio
che sgorghi o scenda verso il mare.
Da una parte la via d’uscita verso il mare è anche il ritorno a un paesaggio che ha dominato l’infanzia del poeta: da qui la dolcezza del ricordo in alcune belle pagine in Filigrane. Ma Garufi ci tiene a chiarire che la sua nostalgia non ha nulla a che fare con un rimpianto reale verso quella stagione, si tratta bensì di una questione di poetica: la sua è un’evocazione poetica di un tempo che non era storicamente migliore del presente; la tensione del maceratese è sempre quella di preservare il “poetico”, in questo caso grazie alla funzione pascoliana e leopardiana del ricordo.
Da un altro punto di vista il maceratese fa propria l’antica lezione di Callimaco, secondo la quale il poeta deve percorrere strade non battute (solo grazie ad uno sterminato bagaglio di letture); anche da questo versante è possibile comprendere certo preziosismo lessicale, un repertorio che approssima l’autore alla stagione del Primo Ermetismo. Di nuovo non si tratta di una questione meramente estetica. In fondo il marinaio della Ballata di Coleridge sa che può raccontare la propria storia solo a chi, lo riconosce in viso, sa ascoltarla. Chi cioè può vedere quei “lapilli di luce” o rifrangenze, quelle “intermittenze” o vibrazioni, come un rabdomante, chi sa farsi medium o transistor tra il mondo dei vivi e dei morti nella dimensione parmenidea dell’Essere. Da qui la scelta di Garufi, giudicato quasi troppo novecentista dalle correnti più in voga; la scelta di un lessico volutamente aulico, sostenuto, che richiede un ascolto intenso da parte del lettore. Una poesia volutamente poco accattivante, ma che proprio in quel punto cerca la complicità con il lettore stesso.
(Fine prima parte)
