Dove una volta c’era una durevole casa, si mostra
obliqua un’astratta figura, totalmente legata al concetto,
come se abitasse ancor tutta nel cervello.
Vasti cumuli di forza si crea lo spirito del tempo, informi
come la tensione e l’urgenza che da tutto esso procura.
Templi più non conosce.
(Rainer Maria Rilke, VII Elegia duinese)

Per entrare nell’ultima, corposa opera di Gabriele Via, Esilio e Natura (edito negli ultimi mesi del 2020 da Carabba, a cura di Luciano Vitacolonna), il lettore di poesia necessiterà di alcune indicazioni preliminari. Ci si trova infatti di fronte ad una scrittura poliedrica, ardita ed estremamente esigente, non tanto dal punto di vista dei fittissimi richiami culturali, quanto per la rara capacità dell’autore di far convergere nella stessa sede testuale variazioni e microvibrazioni di tono e di spessore culturale che generano dei veri e propri cortocircuiti del senso comune, presentandosi come testi che apparentemente promettono una direzione per poi mostrare, alla fine anche della stessa frase, un completo stravolgimento e straniamento rispetto all’impressione iniziale. La difficoltà principale di questo libro, forse, risiede nella sua essenza caleidoscopica, nel fatto che le tematiche principali si diano moltiplicate e racchiuse allo stesso tempo su una superficie riflettente, in una sorta di sala degli specchi in cui è difficile distinguere l’ingresso dall’uscita, il soffitto dal pavimento.
È lo stesso poeta ad affermare che tutto il libro è in realtà la moltiplicazione degli spunti che nascono da un solo soggetto di riflessione: “Scrivo ormai sempre / la stessa unica poesia / perché una è la mia ricerca / e la poesia divenuta mia voce”.
L’opera di Via, più che accompagnare il lettore dall’esterno all’interno del labirinto, lo porta direttamente al centro, senza alcun proemio o catalisi ermeneutica, in modo che Esilio e natura si presenta – più che come un labirinto – come una groviera, dove le varie parti comunicano tra loro senza soglie o frontiere riconoscibili. Scorrendo poi l’indice e ricucendo i titoli delle sezioni si nota come questa groviera possa assumere una forma di romanzo, di storia che dilaga nei versi: L’esilio inizia sempre prima dell’esilio (Alla parola lo spirito restituì la voce); Esilio (quando l’esilio possiede la sua mancanza) divisa a sua volta nelle sezioni La ricerca del sentimento e Falsi di morte per vera musica (morire e sopravvivere. Una variazione improvvisa in tempi di esilio); si apre poi la seconda grossa partizione Natura (natura dimenticata e Natura ritrovata) che si divide in Natura dimenticata (l’emozione di un’eternità che ha dimenticato il suo nome), Natura ritrovata, La legge del mare, Prima dei fiori. In questa situazione fluida alla Escher, questa breve nota si limiterà a fornire alcuni spunti, alcuni punti cardinali che possano guidare il coraggioso lettore all’interno di questa opera. In primo luogo si parta dal titolo.
Esilio e natura contiene in sé una polarità (rispecchiata solo in parte nelle varie sezioni del libro, che parzialmente contraddicono la dualità tra i due termini proponendo un orizzonte più frastagliato e mosso) che rispecchia tradizioni di pensiero ascrivibili all’ebraismo (esilio come Esodo) e al romanticismo. Entrambi i termini rappresentano una separazione, un dialogo mancato: la natura è infatti privazione del sé (anche – per rimanere all’interno di un orizzonte molto presente nel testo – in termini presocratici, se si intende la natura come apeiron), l’esilio la privazione delle proprie radici, l’immersione nella dimensione dell’altro, l’essere altro. Se Natura, nel libro, sembra essere veramente interpretabile in maniera schellinghiana, essendo al contempo il regno di tutto ciò che vive e al contempo lo Spirito che vivifica il tutto, Esilio merita un breve approfondimento. Prendendo in prestito alcune parole di Blanchot si potrebbe definire l’esilio come l’atto di nascita dell’ebreo, che è “l’uomo delle origini, che nel riferirsi alle origini non resta ma si allontana, e così proclama che la verità dell’inizio sta nella separazione. Come israelita è nel Regno, come Ebreo è in Esilio, ed è quasi destinato a dare dell’esilio un regno”[1]. È in questo allontanarsi dall’origine che Via matura la sua riflessione poetica, la sua filosofia in versi; nella tensione fra esilio e natura, nel campo di forze fra ammutolimento naturale e babele dell’altro, la poesia si inserisce come chiave di volta del destino umano, privandosi del potere romantico di creare altri universi e di quello consolatorio della liturgia nel suo mancare sempre l’appuntamento decisivo con l’Altro. Esilio e natura si pone come un’enorme tumefazione all’interno del corpo dell’umano, aprendo una crisi e una rimodulazione di tutto ciò che può definirsi “il rimosso” della società a partire proprio dalla parola che, ancora con Blanchot, è il “luogo in cui gli uomini si tengono in rapporto con ciò che esclude ogni rapporto: l’infinitamente Distante, l’assolutamente Estraneo”[2].
È proprio la critica alla società uno dei fili dell’arazzo che maggiormente risaltano all’occhio. Uno dei primi testi del libro si apre proprio così: “A me risulta che abbiamo sbagliato / l’impostazione di tutta la cosa. / Ed è talmente evidente… […] /
Ed è talmente evidente / la cecità dei numeri”. La società, per Via, è depotenziata dalla sua devozione all’oggetto e all’oggettualità, alla sua riduzione positivistica di tutto il dato umano che la rende barbara, vichianamente in preda ad una “barbarie della riflessione” che si mostra come un heideggeriano e severiniano dominio della tecnica: “L’umanità deve / crescere, ma ha strutturato / una società che glielo impedisce / scatenando meccanismi autodistruttivi: / topi in gabbia che si azzannano / per restare nella fede della vita”. Il nome di Roberto Roversi emerge spesso in queste pagine, ponendosi emblematicamente come l’araldo ideologico del poeta-Cassandra che tenta di riportare in primo piano i problemi dimenticati o obliterati dal tempo presente. Insieme a Roversi, Via si ispira a un certo Leopardi (quello della Palinodia, per esempio, quello della Ginestra) e al Rilke del Malte e del Libro d’ore.

Proprio sulla scia dell’ultimo testo rilkiano è possibile introdurre il secondo leitmotiv dei versi di Via, ossia quello della critica ad una religiosità liturgica e fissa nello stesso delirio di oggettività della società. “Dio è morto”, “Dio sta continuando a morire” sono i frammenti nicciani più spesso ripetuti nel libro, quasi delle emersioni carsiche di un retropensiero che si incarna nell’apoftegma (d’altronde l’affinità dello stile di Via con la forma epigrammatico-sapienziale è messa in luce da Vitacolonna nella sua postfazione). Nella poesia intitolata Forse si ha probabilmente l’esplosione massima di questa carica eversiva di matrice dionisiaca, in cui la figura tragica del Cristo viene ridimensionata a misura umana, in una reductio borghese che atrofizza lo stupore divino: “Ci sono poi quelli / che credono in un Gesù medio, / non piccolo come un fanciullo, / non grande come un gigante. / Un Gesù mediocre, come loro. […] / E tutti questi piccoli mostri / figli d’uomo impaurito / generati dal sonno della ragione / ce li siamo coltivati in seno / dentro le istituzioni democratiche / tanto simili ai ranghi / dei sistemi totalitari fascisti”. Gli esempi potrebbero continuare.
A questa pars destruens Via oppone una paradossale formula di costruzione, una edificazione per verba di un nuovo pensiero filosofico (Via definisce la sua poesia “esercizio / linguistico del pensiero”) non più concettuale ma sensuale, un pensiero del corpo e dello stupore. Per richiamare il nome di Vico (nome che non compare mai direttamente nel testo ma cui Via occhieggia in almeno quattro o cinque luoghi), la pars costruens di Esilio e natura è da ritrovare nella poesia e nella parola; non però nella poesia canonizzata e divisa per generi, quanto nella poesia intesa (vichianamente appunto) come voce e come teologia, come inaugurazione di senso del mondo in relazione a un legame col sacro e con il metafisico ( in opposizione alla contemporaneità: “Qui è consumo, efficienza e scarto. / E la barbarie di aver smarrito / il sacro. Interrotte / le comunicazioni col mistero / della natura”). Via si fa poeta teologo e raccoglie nella sua poesia tutto il materiale umano per poi bruciarlo nella trasfigurazione poetica.
Una trasfigurazione che, si badi, non tende alla concettualizzazione del reale e del divino, quanto a una fibrillazione del reale che lo renda ancora più reale, ancora più capace di stupire con la sua presenza, anche tattile, anche sensuosa. Le tappe di questa identificazione della poesia come forza trasfigurante sono appunto quelle che dall’esilio porta alla natura e viceversa, in un punto medio che è quello del canto. “Non è nel silenzio / ma nella parola / che abita / la vera solitudine. // Dio è nel nulla, / sottile / persuasivo / continuo / incessante”; “Il prossimo Vangelo è una biografia cosmica / irresistibile poesia elementare. / Il resto non lo posso dire; è già qua”; “Preghiera è tutta la poesia: / è tutta quanto vale. / […] La preghiera / è la formula verbale che lega / l’umano a ciò che sta oltre / ogni altro limite possibile / e impossibile. La poesia / è il privilegio della recluta stupita, / chiamata a vegliare: / sentinella sul nulla”; “In questi miei pensieri condotti al limite, / mentre mi abbandono come un sasso nella risacca, / compreso l’ingenuo e ostinato tentativo ) di ragionare di metafisica e di estetica col mio cane, / riconosco la solitudine di tutte le cose; / l’invincibile silenzio / che decreta lo statuto delle parole, / lo spazio del loro originario pensiero, / e quanto sia ingannevole / la provvisoria ragione del capire / davanti all’esperienza sensibile / del sovrabbondante”.
I momenti più convincenti di questa poesia sono quelli in cui l’incarnazione del Verbo si fa tale che le due facce del simbolo, quella metafisica e quella sensibile, combaciano perfettamente, quando appunto la parola si fa voce e gesto: “La realtà fermenta, così intestina / fino a che riesploderà in un canto / inedito e subito accolto, / come un pane franco fra le mani / rivelando sapienza di lieviti arcani”; “Per scrivere una buona poesia occorre / la sapienza sintetica / di tutte queste cose”; “Capirai allora che la vita è una / domanda di carne, che scruta / nel respiro celeste delle cose”: “E a questo punto come faccio io / a parlarti della vita, se non posso / dirti cos’è l’origano, o l’umore / di una torrefazione, vicina la sera / per i vicoli tiepidi di Crotone o Messina?”.
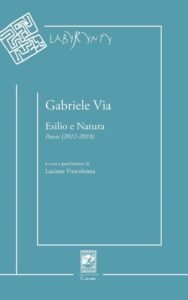
Nel crinale in cui si compie la metamorfosi da poesia a gesto, da pensiero filosofico a masticazione, sorge spontanea la domanda sullo stile di Gabriele Via, sull’effettiva resa poetica di questi testi. Come si sarà intuito il codice lirico – deputato di solito alla rampogna etica e metafisica – non è il principale strumento adoperato dal poeta; le metafore non sono ricercate, il vocabolario (tranne alcuni rari esotismi che percentualmente scompaiono nel flusso dei versi) non è ardito, il ritmo non è marcatamente endecasillabico o altro. Si è in una situazione onnivora, in cui il poeta fagocita (quasi postmodernamente) tutto il materiale linguistico della quotidianità. La strabiliante capacità di Via sta nell’accostare (come in un crepuscolarismo metafisico) la concretezza del dato reale alla nudità dei riferimenti filosofici e letterari privati di qualsiasi introduzione o volontà di citazione (ad esempio, due su mille, “Stanotte la terra ha tremato ancora / mentre una rondine tornava al tetto”, “Trasfigurazione è la fine delle cose: / Anassimandro e l’evidenza del bagnasciuga”) nella volontà di privare l’astratto della sua fascinazione intellettuale e il concreto della sua presunta rozzezza. La resa pop di questi riferimenti, dove la Qabbalah convive con Asterix e Obelix, o dove Severino Boezio è accostato al tortello bolognese, ricrea l’impressione di un mostruoso (alla latina) Blob che assorbe e ingurgita le distinzioni e le rappresentazioni, le tare dello sguardo. In questo amalgama (che è anche miscuglio di tonalità, dall’enumerazione compulsiva allo schizzo di una breve pioggia), in questa voce ruminante, è chiaro lo scopo di Via: dimenticare le tonalità, dimenticare l’armonia e la melodia, il galateo e la moda, per ridonare al lettore non una poesia di maniera ma, sostanzialmente, una timbrica, una materialità sonora.
Gabriele Via è anche attore di teatro e sembra che anche questo libro conservi le modulazioni sceniche della voce; una parola che si fa canto controllato, una ricerca verbale che è in primis trasfigurazione timbrica, una scrittura che si fa gesto agito. Se non si volesse riconoscere l’appellativo di poesie a questi testi di Via, il fatto di ricevere l’impressione di avere a che fare con dei gesti e con delle azioni tangibili basterebbe da solo a smentire i malevoli critici. Gabriele Via con le sue poesie agisce il mondo, lo ricrea, ed è veramente poietes, e il suo libro, con le parole di Emanuele Severino poste in esergo, “è chiaro che […] serve a pensare, ma non è la lettura lo scopo”, quanto la rimodulazione di uno sguardo, la sua pulizia metafisica.
_____________________________________________________
[1] Maurice Blanchot, La conversazione infinita, Torino, Einaudi, 2017 p.154
[2] Ivi, p. 155.
