
Sono uscite, per i tipi di Interlinea, due antologie, rispettivamente dedicate alla poesia (nel 2020) e alla narrativa sulla Shoah (in questi giorni). Le ha curate Giovanni Tesio, che abbiamo intervistato.
FD – Ti conosco da molti anni e mi è nota la tua passione per l’opera di Primo Levi. La domanda più ovvia. Come nascono le antologie Nel buco nero di Auschwitz e, poco prima, quella Nell’abisso del lager?
GT – Molto naturalmente, ossia per naturale disposizione. Nel buco nero di Auschwitz non è che il seguito della precedente antologia, Nell’abisso del lager. La prima era dedicata a poesia e Shoah, quest’altra è dedicata a prosa e Shoah. Ma tutt’e due nascono dietro l’impulso dell’editore novarese di Interlinea, Roberto Cicala, che mi ha fatto la proposta, ben sapendo anche lui della mia passione per l’opera di Primo Levi.
FD – È stato quindi Levi a fare da ponte.
GT – Direi proprio di sì, e direi anche che nelle due antologie è Levi a fare da dorsale, a costituire il centro delle mie considerazioni e delle mie scelte. Una presenza su cui ho molto insistito nelle due introduzioni.
FD – Questa l’origine, ma i perché?
GT – I perché, tanti. Ne posso indicare alcuni: uno, il desiderio di far partecipi i lettori di pagine sparsamente conosciute, ma qui tutte raccolte (tutte, intendo, quelle che ho deciso di raccogliere, una settantina); due: comporre un mosaico di voci che contrastino la deriva della memoria, il suo affievolirsi (quantunque io sia poi fermamente convinto che anche l’oblio abbia i suoi meriti: diceva Marc Augé che elogiare l’oblio non significa affatto vilipendere la memoria, ma comprenderne meglio le dinamiche); tre: invitare, come diceva Primo Levi, a conoscere, a riflettere in tutti i modi al dramma e alla tragedia di un fatto enorme, unico, ma non definitivo, quattro: valorizzare il meglio delle scritture in cui le testimonianze restano incise. La loro, diciamo pure, letterarietà.
FD – Tra testimonianza e scrittura c’è dunque compatibilità?
GT – Eccome. Fin da quando ho letto per la prima volta Se questo è un uomo (su cui ho poi scritto anche uno dei primi saggi sistematici della bibliografia su Levi), non ho potuto non rendermi conto che tanto più evidente era la sua letterarietà quanto più forte il suo valore testimoniale. In altre parole la “ricreazione” letteraria contribuire a imprimere al testo una ricchezza che della letteratura non prende i vizi ma le virtù. Del resto questa quota necessaria è stata sottolineata da tanti testimoni-scrittori. Non solo Primo Levi, ma Robert Antelme o Jorge Semprún. Se si può pensare che la letteratura sia un inganno, non si deve dimenticare che questo presunto “inganno” può diventare un elemento fondamentale di conversione del vero in verità. Del resto a fronte di tanti divieti o di domande perplesse, la letteratura ha compiuto i suoi passi e costituisce un nucelo forte della testimonianza concentrazionaria.
FD – Anche le introduzioni che hai scritto sono molto dense e articolate, segno del grande lavoro a cui ti sei sottoposto per giungere a questo risultato che – consentimi – è straordinario. Possiamo, dunque, parlare di un dittico tra poesia e prosa.
GT – Proprio così. Siamo partiti con la poesia ben memori del divieto, poi rientrato di Adorno, che in un primo tempo aveva sentenziato: “scrivere poesia dopo Auschwitz è barbaro”. Ed è stato al tutto immediatamente evidente che di poesia se n’è fatta molta, addirittura in Auschwitz e poi evidentemente dopo. Poesia, in questo caso, anche di chi l’esperienza tragica di Auschwitz non l’ha vissuta, ma l’ha presa in considerazione nelle sue riflessioni e nelle sue urgenze espressive, da Sereni a Pasolini a Zanzotto e potrei continuare.
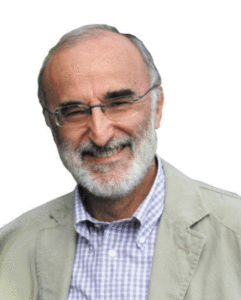
FD – E per quanto concerne la prosa?
GT – Prosa a partire non diversamente dalla considerazione di Carlo Levi: “Che romanzi volete che ci siano, dopo Auschwitz e Buchenwald?”. Non solo romanzi, naturalmente, ma prosa testimoniale, prosa epistolare, prosa diaristica, prosa teatrale, prosa di romanzo. E anche qui pagine di chi ha patito il lager e pagine di chi ne ha fatto occasione di racconto, fino a Dürrenmatt o a David Grossman, che il lager non lo hanno vissuto. Un universo enorme, un bacino che tocca i continenti e che di per sé è talmente grande da mettere in seria difficoltà chi se ne voglia orientare. Ma noi abbiamo giocato – dico noi per comprendere con me anche l’editore – la nostra scommessa e io credo, senza presunzione, che attraverso una settantina di voci un orientamento ne sia emerso.
FD – Quando ho finalmente avuto in mano il volume della poesia, prima di dedicarmi alla tua introduzione, non ho potuto fare a meno di aprirlo a caso e imbattermi in una poesia che mi ha commosso fino alle lacrime e che vorrei proporre ai nostri lettori, è di Lodovico Belgiojoso, datata febbraio 1945:
*
Quattro respiri in una stanza buia
un sospiro più forte e un fruscio
di lenzuola,
i miei passi che scendono le scale
senza far rumore.
È l’ultimo ricordo
che ho dei miei figli e quei quattro respiri
riportano vivi alla mente
il sorriso della Bica
il musino della Pupa
il faccione del Bico
gli occhi del Gianni.
Ogni volta che qui scendo le scale
mi par di farlo in punta di piedi
per non risvegliarli;
forse dormono ancora!
FD – Tra i tanti nomi, ce n’è qualcuno in particolare che vuoi segnalare tu?
GT – In verità vorrei dire di no, perché mi pare che le voci che ho raccolto siano tutte degne di attenzione. Le due antologie mi pare che abbiano il pregio di prestarsi a una lettura non necessariamente sistematica. Io credo che sarebbe pur bello immaginare un lettore che giorno dopo giorno si accompagni con qualche riflessione che parta da qui, e se poi questo è un sogno non mi pare che sia un sogno disdicevole. Ma ho tuttavia avuto – perché negarlo poi? – alcune predilezioni. E tra queste ne dico due perché mi sono parse eccezionali: la voce di Etty Hillesum, sia dal Diario sia dalle Lettere. E la tutt’altra voce di Günter Anders, di cui riprendo qui una poesia che mi era sfuggita nella prima antologia. Bellissima. E tanto attuale. O attualizzabile.
FD – Vogliamo riprenderla?
GT – Volentieri. Eccola. È così vero che la quantità dei morti ne annulla in noi il senso di catastrofe, di disastro, che è proprio, in ebraico, il senso della parola “Shoah” che Primo Levi preferiva largamente e motivatamente alla parola vittimaria di “Olocausto”.
*
Se solo in tre levassimo la voce
– tre accusatori di un flebilissimo coro –
troveremmo subito la via del vostro ascolto
e con facilità del vostro cuore.
Padre madre e figlio sono una triade
e ogni cuore potrebbe contenere tre morti.
Ma noi milioni oggi siamo già dimenticati,
perché noi milioni siamo troppi.
Sì, troppi. I troppi non hanno voce.
E non soffrono. E possono decomporsi.
Avete letto fuggevolmente la cifra,
girate in fretta la pagina.
Ma se non negate affatto la nostra morte,
allora scendete nelle nostre fosse
e raccogliete dalle nostre labbra l’annuncio
e portatelo in ogni dove. Perché fintanto,
fintanto che i forni saranno negati
e le macine che ci spezzarono,
fino ad allora a noi che siamo cenere e ossa
non sarà concesso essere morti.

