Si inaugura la rubrica di poesia “In bottega”, con l’obiettivo di proporre il lavoro in progress di poeti contemporanei, invitati a dialogare con “Nuova Ciminiera” e con i lettori rispetto alle loro scelte formali stilistiche e retoriche, curiosando all’interno della loro officina o meglio, della loro bottega, tra i ferri del mestiere. Il fine è quello di accostarsi ai diversi procedimenti espressivi nell’atto dello scrivere, entrando nel dibattito, tutt’altro che esaurito, delle forme poetiche prima e subito dopo e intorno agli “anni zero”. Ha ancora senso maturare una consapevolezza metrica, stilistica, al pari di una esperienza della realtà che sia connaturata alla lingua poetica e con essa proceda ? O forse il cambiamento antropologico dell’uomo poetico nostrano ha reso ormai inutile ogni discorso? Riteniamo di no, anzi, siamo convinti che si tratti di un ufficio doveroso e intrigante, alla luce dell’osservazione di come le poetiche abbiano lasciato il passo a una proliferazione di voci, ciascuna portatrice di un’eredità, nella dispersione di questi anni. Siamo convinti sia necessario entrare con una telecamera in quelle dicotomie che caratterizzano ancora oggi una pluralità multiforme di voci per capire, ad esempio, se ancora esiste un quid formale che dia indicazione della poeticità di un autore, almeno dal momento in cui sono stati “accantonati alcuni modelli fondamentali della prima parte del ‘900 e ci si è indirizzati verso una soggettività lirica, ancora oggi dominante, come alcuni esempi mostrano. Senza dimenticare, nelle differenze, quelle esperienze di scrittura che si sono riproposte secondo istanze dell’io a diversi gradi, dal minimalismo pseudo-autobiografico, a una scrittura iper-formalizzata oppure, all’opposto, tendente a un grado zero o comparabile alla prosa. O ancora scritture volte a destituire la funzione di un soggetto che scrive per la pagina per assecondare un soggetto che pensa alla scrittura come recupero dell’oralità, che abbia il proprio destinatario in un pubblico di ascoltatori (il poeta performer); o un soggetto installatore di uno spazio da condividere e per cui il messaggio si incentra in chi guarda. Insomma, il ventaglio è ampio, circolare come la coda di un pavone e non resta che aprire a tutto ciò che nel giro di alcuni decenni ha contribuito al passaggio da un “pubblico della poesia a una poesia senza pubblico” o meglio, con un unico pubblico composto unicamente di poeti. Senza dimenticare il ruolo fondamentale che la critica e l’editoria hanno avuto nel ‘900 fino a Fortini, Sanguineti e Pasolini. E non può essere certo la “mancanza di ideologie” a decrementare una tale indagine nei procedimenti della scrittura poetica in seno all’osservazione del mondo e delle sue ingiustizie e della dialettica che è sempre presente a un certo grado anche in quelle scritture non dichiaratamente di impegno ma autoreferenziali, perché non c’è epoca più ideologica di questa che stiamo vivendo, per quanto la funzionalità sociale della scrittura sia meno incisiva rispetto a prima. Insomma, vediamo dove conduce questa navigazione solitaria, ciascuno nella sua “parole”, in una spaccatura con il linguaggio poetico che evidentemente ha bisogno di mutare prospettiva rispetto al proprio referente.
I posti a sedere dei vivi e dei morti di Luciano Mazziotta

Siamo ben lieti di inaugurare la rubrica con Luciano Mazziotta, autore nato a Palermo e bolognese di adozione, che ha pubblicato, a parere di chi scrive, uno dei libri di poesia più interessanti dell’anno, vale a dire Posti a sedere, edito da Valigie rosse nella pregevole collana curata da Paolo Maccari. Si tratta di un libro che colpisce subito il lettore per la densità espressiva, la costruzione macrotestuale, le scelte metriche, le relazioni che instaura tra lingua poetica e discorso, fuori dall’ordinario rispetto a quanto potremmo aspettarci da un libro di poesia oggi. Di interesse precipuo è anche la riflessione che vi si intuisce tra tempo della rappresentazione e storia intesa nel suo divenire, dal momento che il testo appare come una scansione visiva di quadri mobili che nella “narrazione” assumono un preciso significato, poiché è intenzione dell’autore raccontare una vicenda, come si avverte fin da subito nel testo di apertura (“con qualche difetto appena visibile/ devi restare immobile.// è questo il posto questo/ il racconto concesso.”). Riflessione che incrocia anche quella filosofica del pensiero occidentale (Mazziotta ha principalmente una formazione classica) rispetto al rapporto tra totalità e particolarità del mondo da rappresentare, nel senso che la totalità (vita prossima alla morte) irrappresentabile viene ridotta a una rappresentazione di tipo “narrativo”, appunto, e con un procedere allegorico per cui i quadri della visone che si succedono sembrano miniaturizzati per poter porre le raffigurazioni sul piano dello sguardo del fruitore. Ma il testo, d’altro canto, induce a riflettere anche sui procedimenti ritmici e metrici, che tanto tengono conto dell’uso dell’esametro e dei metri tradizionali italiani, dal settenario al novenario che, per caratteristiche, ben si inseriscono nel montaggio per cui i contenuti vengono a concatenarsi rispetto ai temi, anche questi ultimi selezionati a priori, nel senso che l’autore vuole invitarci ad assumere un punto di vista parlandoci proprio di quel tema e non di un altro. Evitando in tal senso la spontaneità dell’ispirazione creativa lirica e, anzi, mettendo in black out le istanze di un io lirico inteso come da tradizione, ancora dominante, e su cui tanti prodotti poetici sono ad oggi incentrati. Il soggetto dell’enunciazione viene qui a corrispondere a una dimensione prospettica tra le altre, perdendosi ad un certo punto in una delle visioni, quella centrale, in un gioco di riflessi e di sguardi, a partire dal proprio sentire “patico”. Non si tratta quindi di un io che scrive di un accadimento di cui è protagonista cercando poi di universalizzarne l’esperienza come da un’unica fonte di enunciazione.
La vicenda di Posti a sedere si avvia con la sezione Questo posto, abitato da un disordine percettivo caotico dove nessun ordine temporale ha luogo e può farsi trama, come un’origine dove gli elementi della natura siano allo stato disorganizzato e senza farci comprendere, l’autore, chi sia l’artefice di una tale entropia dell’abitare, se la natura sia stata indotta a implodere in se stessa o se sia l’indecifrabile architettura connaturata alla nostra stessa radice umana. Fatto sta che si inscena, come in una sospensione letargica, che sembra appartenere a nessun tempo, una casa mondo privata di mondo, come se il logos ordinatore implodesse in se stesso. E in questo posto i vivi e i morti, refrattari ad ogni smascheramento “psicologico”, senza più coscienza, si prolungano nella vita degli uni negli altri, come se non ci fossero più differenze: gli ospiti sono fantasmi, gli oggetti alla stregua di presenze e le presenze sono oggetti tra gli altri, ora animati e ora inanimati e captati da una percezione che fa parte allo stesso modo di questo spazio organico che si perde nell’inorganico, che ha alzato il suo livello di indifferenziato esondando all’interno dello spazio abitabile del corpo casa e del corpo abitante. Un inedito ecosistema che ha preso il sopravvento: alghe, blatte, fango, palude, incubi, spazi che crollano, minerali, cimici, traumi, rimorsi, questo il lessico ricorrente. Come se il corpo abitato avesse rescisso ogni legame con l’abitabilità della propria vita, in esso si innestano reperti di ogni sorta come oggetti di una materialità che principalmente è un impasto organico e inorganico della morte, che tanto ricorda il caos senza possibilità di redenzione dopo l’esaurimento storico delle “Composte terre in strutturali complessioni sono Palus Putredinis” di sanguinetiana memoria, cui fa eco l’esergo tratto da Cemento di Thomas Bernhard: “La casa non era vuota, era morta. E’ una cripta, pensavo”. Allora il posto della nostra abitabilità è forse il luogo dell’impossibilità di ottenere un qualsiasi risveglio rispetto agli spazi di realtà concessi.
Anche nel momento in cui alcuni personaggi emergono dal caos primordiale descritto nella prima sezione del libro in situazioni “reali”, restano impaludati in una comunicazione senza messaggio, come se i soggetti non coincidessero mai nella coesistenza dell’immagine che li rappresenta tra le pieghe del male, che è uno dei temi fondamentali del libro, se non il tema precipuo. Essi restano preda di un legame che si avvolge nella spirale del negativo, non potendo che manifestare odio anche nel tentativo di amare, come recita il refrain che puntella quasi tutti i testi della sezione “Fanno spazio”. Lo spazio del male coabita nella relazione che qui si avvicenda in scene osservate da uno sguardo distanziato e impersonale, dove l’hospes inabitabile a se stesso e all’altro si ripiega in hostis, nel senso di ostilità, che implica nella coppia un atteggiamento di condanna, di rifiuto. Senza alcuna partecipazione empatica, se non quella di registrare l’impossibilità di uno stato prossimale tra i soggetti e preparando il lettore, o meglio il visitatore, alla sezione di “Case museo”, parte centrale e poeticamente più alta del libro. Qui la vita e la morte sono museificate, ridotte cioè ad una forma che coincide con una totalità assolutamente rigida e si susseguono nelle due visioni del libro: “Il trionfo della morte” e la “Cripta dei cappuccini” (che si trovano nella città biografica dell’autore, a Palermo, una nel museo di Palazzo Abatellis e l’altra nelle catacombe della chiesa di Santa Maria della Pace). Di fronte alle visioni reali e allegoriche cui l’autore ci conduce si può scorgere il riflesso delle cose di fronte alla loro caducità per cui a nulla vale la vanità delle gerarchie sociali e della rappresentazione del loro potere immortalata in una forma come gli esemplari della casa museo suggeriscono (le immagini sono facilmente reperibili in rete): un affresco “staccato” e rimosso dal luogo originario in cui era stato collocato e l’imbalsamazione di persone abbienti della città per lasciare dopo la morte la migliore immagine di sé. Pertanto in tali visioni, già stranianti nella realtà per via della somiglianza dei morti ai vivi, viene rappresentato un rovesciamento prospettico e mimetico tra chi guarda e chi è guardato, appartenendo allo stesso mondo qui allegorizzato nel contemporaneo, come se l’autore ci costringesse a osservare attentamente che le differenze tra le due dimensioni siano meno nette di quanto possa sembrare e conducendo lo spettatore a un’opera di deallegorizzazione al fine di riprendersi uno spazio più autentico di vita, per non essere parte dei posti a sedere. A questa operazione deallegorizzante lo spettatore è chiamato a misurarsi, al fine di riportare l’angoscia della totalità alla dimensione terrena immanente e renderlo partecipe, per chi è in grado, di un’esperienza innanzitutto demistificatrice. La vera arte del poeta – dice Aristotele – è quella di rendere lo spettatore il “possessore cognitivo” (la “parafrasi” è di Andrea Inglese) di quella figura di mondo che gli è posta di fronte”. E’ chiaro come l’ironia diventi, nel dispositivo delle visioni, un procedimento a lenti focali variabili, a gradienti mi verrebbe da dire. Perché lo sguardo ironico che ci avvicina e ci distanzia rispetto al nostro destino in vita e in morte è quanto mai calibrato qui dall’uso sapiente della lente ritmica e sintattica, che abbandona ogni discorso per farsi tramite tra chi osserva e chi viene osservato, come si accennava. Nell’opera di deallegorizzazione, che induce a un’attenzione ai contenuti della nostra essenza di essere umani di fronte al male connaturato nel bios e nei suoi dispositivi sociali di sopravvivenza della specie, non resta che uno sforzo percettivo e sensibile, appunto, per destrutturare lo spettatore interiormente, ossia per farlo uscire alla scoperto nella nudità del suo vero. In tal senso Mazziotta è poeta politico, anzi, biopolitico, e con una forte tensione etica. Quello stesso slancio che lo conduce a perdersi in una specie di sindrome di Stendhal, nella rete delle illusioni di vita e di morte cui l’artista è artefice, come suggerisce il bellissimo testo poetico a pag. 55 (“allora perché/ scrivere un trionfo se è trionfo del niente/ se i supplici supplici restano se la tua ombra/ nemmeno combacia con l’autoritratto/ pittore. e perché non sai uscirne chiedilo a lui/ autoritratto tra i supplici come se un ragno/ tessuta la tela ne fosse l’autore e la preda/ e ciò nonostante è minaccia di resa/ e ciò nonostante ti fissa/ commosso che tu sopravviva e ciò nonostante/ non riesci ad uscire dal trionfo”). Difficile qui non pensare, come ipotesto, ai Trionfi del Petrarca, come il titolo del poemetto oltretutto suggerisce. Anche lì, in forma di visione, appariva l’aspirazione del Petrarca all’unità vera di sé, tanto che narrava di assistere al “teatro” delle varie figure allegoriche (Amore, Morte, Fama, Tempo, etc..), riflettendo, rispetto ai personaggi storici e mitologici delle scene chiamati in causa, sul significato dello scorrere del tempo che cancella ogni cosa, soprattutto ogni tentativo da parte dell’uomo di poter vincere sulla morte, di renderla cioè vana attraverso la gloria o la fama.
Ma come si accennava, il “racconto” scaturisce e si configura in una versificazione fortemente ritmica, quasi a voler bucare la superficie del discorso al fine di imprimerne un’altra modulazione espressiva. Il linguaggio poetico non si adegua al discorso di tanta poesia piana, ma tende a percuoterlo, a intesserlo dall’interno e dall’esterno, a trapassarlo da sopra e da sotto, applicandosi al linguaggio come una sutura instabile e che destabilizza il lettore ma, ancor prima, le immagini che si vanno rappresentando, fino a non comprendere di chi sia il movimento allocutorio, il primo passo certo. Non è un ritmo volto a pacificarsi in una struttura metrica ma, al contrario, sembra il metro qui adeguarsi ai sobbalzi ritmici. Si tratta del procedere di una voce che non vuole adeguarsi, rispetto ai contenuti di cui si è detto, a un principio ordinatore, regolato nella misura del suo movimento, ma un ritmo che si modula in un flusso di configurazioni momentanee, dinamiche, che seguono il passo e la distanza di chi le osserva allo scopo di farne esperienza propria e, al contempo, collettiva. E d’altronde questa è la vera natura insita nella relazione tra metro e ritmo, tra regolarità e movimento, forma e modulazione di un flusso, tra configurazioni momentanee e struttura dell’organizzazione biologica, subordinazione e insubordinazione. Mazziotta innesta un ritmo “percussivo”, come è stato detto, al fine di suggerire una diversa disposizione del soggetto secondo prospettive volte a rendere il fenomeno non immediatamente interpretabile e soprattutto non ordinabile in un disegno trascendente. Si tratta del ritmo di un respiro che induce, a chi lo attraversa, ad afferrare la propria individualità contraddittoria e di saperla indefinibile nel qui e ora e nella durata del divenire che non ha tempo se non nelle leggi strutturate dall’ordine naturale cui è legato. Come affermava Andrea Inglese in un suo bellissimo saggio sul ritmo, “la riproducibilità esatta del metro si impone sulle innumerevoli possibilità di configurare il flusso”, che il poeta di Posti a sedere tenta di liberare, di arieggiare, cercando di portare un po’ di ossigeno alle nostra residue speranze. Ponendo il visitatore/ascoltatore/lettore di fronte a un canale connettivo inedito rispetto ai timori ancestrali della vita come angoscia della fine e relative significazioni che organizzano le esperienze umane, ben oltre quindi la dicotomia natura cultura, ordine e caos, dicibilità e indicibilità, flusso e forma rigida, realtà e rappresentazione etc.
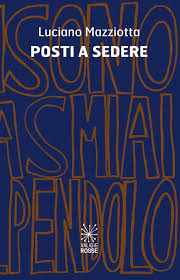
Ne parliamo ora con l’autore, cui abbiamo rivolto una serie di domande:
1) La tua formazione è più di ordine poetico, oppure nei tuoi studi ti sei accompagnato anche da altri ambiti artistici o filosofici?
La mia formazione, in realtà, è più filologico-filosofica. Negli anni universitari, infatti, per quanto frequentassi il corso di laurea in Lettere Classiche, mi sono concentrato maggiormente sui filosofi e i medici dell’antichità, attraverso, certo, gli strumenti della filologia. Platone per diverso tempo è stato l’autore che ho più letto, analizzato e commentato. Insieme a Platone, chiaramente, Aristotele e poi, per varie vicissitudini, Ippocrate e Galeno. Non so in che modo abbiano influito questi studi sulla mia scrittura, ma probabilmente nell’impronta filosofica che cerco di dare ai testi. Quanto alla formazione metrico-poetica, in questo sono quasi del tutto autodidatta, come suppongo la maggior parte degli autori contemporanei. Se, però, per formazione intendiamo quella serie di incontri che si fanno nella vita, quei rapporti di stima tra autori che poi, lentamente, diventano amicizia, allora sì: la mia formazione è del tutto di ordine poetico. Senza questi “incontri – veramente – formativi” avrei non solo non avuto una coscienza sul testo, ma neppure una consapevolezza su ciò che è la letteratura nella produzione contemporanea.
Concludo con l’ultimo punto della domanda: ribadisco la mia totale ignoranza nei confronti delle arti figurative. Proprio per questo, queste ultime mi affascinano maggiormente, in quanto con esse mi sento di poter intrattenere un rapporto più spontaneo al livello di fruizione. Per questa ragione, quando scrivo, cerco sempre di tenere presenti opere soprattutto del passato, mantenendo con esse un dialogo quasi oracolare. Le interrogo, infatti, ponendomi il dubbio di averci capito qualcosa (del loro senso e del senso del mondo). Nel libro precedente avevo provato, del resto, a dialogare soprattutto con Malevic, affascinato dalla molteplicità di significati inclusi nel quadrato nero; in Posti a sedere, invece, ho tentato di spaziare da Ghirri a Bunuel, da Tarkovksij a Bosch, fino ad arrivare ad instaurare un dialogo diretto con l’anonimo autore dell’affresco del Trionfo della morte conservato a Palazzo Abatellis a Palermo.
2) Il titolo del tuo ultimo libro suggerisce il tema dell’ascolto di fronte a una visione, cercando di coinvolgere il lettore/spettatore davanti a quella figura di mondo che gli è indicata dal poeta, può essere questo il compito di chi scrive? E quale messaggio vuoi fare prevalere alla lettura del libro (etico, politico etc…)?
Se ci pensi, Posti a sedere si ascolta, si guarda e si attende. Il problema che mi sono posto nella scrittura di questo libro è soprattutto, ad ogni modo, il che cosa si ascolti, si guardi e si attenda. Il ritmo è fluente, cosa che di per sé potrebbe essere un gioco di parole. Gli accenti sono quasi fissi, quindi si tratta di un testo che può essere, oltre che letto, ascoltato. Possiamo così liberarci di sterili polemiche e facili dicotomie tra poesia e performance. Se è vero che ogni autore vuole essere letto, infatti, è pur vero che lo stesso vuole essere ascoltato, altrimenti non avrebbero senso le figure di suono, i tagli e le cesure che riproducono sonoramente quella che chiami “figura di mondo” offerta. Tuttavia, nel libro, forse questo è l’unico suono che voglio suggerire, il suono del fluire controllato e misurato del verso. Se scendiamo, infatti, a quello che “si guarda”, questo “osservato” è costituito di figure vuote, cave, di vivi che somigliano ai morti e morti che appaiono più vivi dei vivi, e, infine, da foto che non sono state scattate. C’è, dunque, accanto ad una serie di immagini che ho preso in prestito dall’arte figurativa o dalla cinematografia, un continuo rimando alla concezione di un vedere nient’altro di quello che c’è, o, meglio, non vedere niente. Posti a sedere, per concludere, come dicevo precedentemente, si attende. Ma o non si attende niente, o, si attende “una catastrofe in forma di sospiro”, come si può vedere in Melancholia di Lars Von Trier o, ancora più profondamente, in Sacrificio di Tarkovskij.
Così arrivo alla seconda parte della tua domanda, se il compito della poesia possa essere rendere il lettore “possessore cognitivo” della figura di mondo messa in scena dall’autore. Credo che la “figura di mondo messa in scena dall’autore” sia dai contorni affatto definiti, e per questa ragione, più che rendere il lettore “possessore cognitivo”, ritengo si inviti il lettore allo sforzo cognitivo; a procedere per “conoscere” un qualcosa che lettore e autore non riescono ad identificare. Giusi Drago in una recensione precedente ha parlato dei miei testi come di “laminette orfiche del nuovo millennio.” Non che Posti a sedere sia un testo orfico. Nient’affatto. Più che altro, come ha ben messo in evidenza la Drago, ho provato a stare al di qua dell’immagine, in modo tale che il lettore debba sforzarsi per decodificarne i contorni. Credo che, per l’appunto, compito dell’autore possa essere invitare il lettore allo sforzo, con anche la possibilità che questo sforzo non conduca a nulla, a nessuna conoscenza e a nessuna maturità raggiunta. Lo sforzo cognitivo, però, è di per sé una conquista.
Quindi giungo al messaggio: nel corso della stesura del libro non ho pensato a quale “messaggio” volessi far prevalere. A libro compiuto lascio che il lettore si scelga il proprio messaggio in base alle proprie esigenze. Di certo, sono fortemente influenzato da una concezione etico-filosofica della poesia, come dicevo precedentemente, e anche dal Marxismo. A proposito di quest’ultimo ho sempre trovato illuminante la tematizzazione dell’odio come “motore della storia.” Mi piacerebbe in particolare che la seconda sezione del libro fosse letta non come un rapporto di coppia in cui i due soggetti in relazione si odiano, ma come un micromondo in cui questi stessi siano tenuti in vita dall’odio, e, parallelamente, spinti ad andare avanti grazie a questo. In pratica mi piace pensare che non tutti quelli che odiano siano haters, ma che dietro al sentimento di “odio” ci sia qualcosa di molto più profondo, intimo, e allo stesso tempo, etico.
3) Cosa pensi della questione metrico-versoliberista alla luce delle ultime tendenze contemporanee della poesia italiana? E nel tuo caso, ritmo subordinato al metro o metro subordinato al ritmo?
In una bella intervista a Giuliano Mesa, quest’ultimo sosteneva che è quasi scontato ormai parlare di metrica libera. Bisognerebbe chiedersi, per l’appunto, “libera da chi?” Il moto verso-liberista di inizio Novecento è stato una protesta nei confronti delle strutture letterarie precedenti che, ormai canonizzate, sembravano riprodurre dal punto di vista metrico-sonoro le istituzioni politiche e letterarie del tempo. Il verso libero si liberava dall’imposizione di un metro di giudizio che considerava letterario ciò che aderiva in un modo o nell’altro a degli schemi imposti. Nella contemporaneità le strutture letterarie non vanno affatto di pari passo con le istituzioni politiche. Anche le “regole” più ferree, qualora qualcuno dovesse rispettarle, più che costituire un dogma, rappresentano una difesa dalla logorrea cosmica di fronte alla quale ci troviamo. Tanto i versi liberi che quelli chiusi, del resto, a quasi 150 anni da Lucini, sono entrati nel campo della tradizione, senza però venire, per fortuna, assimilati né dal potere, né dalle accademie (se non in casi eccezionali). Verso libero e verso chiuso sono una scelta individuale, e, per fortuna, qualcosa che non viene a contatto con chi detta le regole del mondo – o dell’economia, che sono, tra l’altro, due facce della stessa medaglia. Scegliere l’una o l’altra strada difficilmente significherà aderire a quelle regole del mondo.
Passo, adesso, al secondo punto della tua domanda, niente affatto scollegato con il primo, ovvero il rapporto tra ritmo e metro. Se il ritmo, come diceva Fortini pertiene alla individualità, il metro è qualcosa che risponde alla collettività e alla storia. In un testo poetico, così, ritmo e metro, individuale e collettivo si compenetrano. Difficilmente possiamo rintracciare, del resto, anche nella metrica libera, ritmi estranei totalmente ai metri tradizionali. Se pensi a un testo in cui la metrica esplode del tutto, come La ballata di Rudi di Elio Pagliarani, la stragrande maggioranza dei versi lunghissimi possono essere suddivisi in endecasillabi, novenari e settenari.
Un concetto che mi preme sottolineare, ora, è proprio quello di individualità: se la letteratura non è che un continuo gioco di variazioni sul tema, è proprio nel ritmo, a mio parere, che si intravede l’individualità dell’autore, delle sue nevrosi, delle sue scelte: l’endecasillabo di Tasso, ad esempio, è portatore della sua psiche più di quanto non lo sia il tema scelto. Suppongo che se ogni autore procedesse ad una autoanalisi, e non dico autoanalisi letteraria, ma autoanalisi psichica, troverebbe che la scelta ritmica sia più frutto della propria storia personale di quanto non lo siano le tematiche trattate.
4) Quanto è importante la costruzione del testo nel tuo lavoro e come nasce una poesia, come si sviluppa
Per quanto riguarda quest’ultimo libro ho lavorato in due direzioni: quello microtestuale e quello macrotestuale. Il singolo testo raramente è stato frutto di un’illuminazione estemporanea. Anzi, quasi mai.
Per la maggior parte dei casi ho proceduto, invece, secondo la strategia musicale della jam session. Per ogni testo che compone il libro, infatti, ho scritto almeno una cinquantina di appunti, di improvvisazioni sul tema, di variazioni sul tema. Ognuno di questi testi estemporanei risultavano tanto imprecisi, quanto brutti (secondo le mie categorie estetiche di autoapprovazione). Tuttavia, in ognuno di questi “brani” ho rintracciato un riff convincente, che fosse una sola frase, un futuro solo verso, una “strofa.”. Una volta raggiunti una serie di riff convincenti ho provato a montarli per farne un testo concluso e da licenziare, continuando a limare tanto ritmicamente che dal punto di vista del senso. Le poesie, quindi, sono il risultato di una sorta di cut up di testi abbozzati. Si tratta, chiaramente, di una strategia non nuova, che, fra i miei coetanei, ha spesso adottato Jacopo Ramonda per le sue microprose.
5) Vuoi scegliere un testo dal libro per commentarlo?
Sperando di aver in parte risposto, passo all’autocommento, per il quale sono già sicuro di non rispondere e non saper dire abbastanza. Ho scelto un testo scritto in un momento avanzato della composizione, quando, orientativamente, avevo capito che direzione intraprendere. Si tratta di “Ora se è giorno pensati al buio nel palazzo-museo”, tratto dalla sezione Case-Museo, in cui ho voluto trattare due luoghi emblematici della mia città di origine, Palermo. I due luoghi sono la Cripta dei cappuccini e Palazzo Abatellis, laddove è conservato il Trionfo della morte, il celebre affresco in cui è rappresentata la morte nella forma di un teschio su un cavallo che scaglia frecce a tutta una platea di umani, suddivisi, orientativamente, per classi sociali.
La sezione è composta, per lo più, da testi in distici, con le dovute eccezioni; e se la prima parte è proprio un “viaggio” tra le mummie della Cripta dei Cappuccini, la seconda invece è un dialogo, da fermi, con l’affresco.
Ho immaginato che un tu-lirico potesse rimanere fermo, a museo chiuso, di fronte all’affresco, in un’ora serale e in una data non specificata, come del resto non sono mai chiare e definite le date nel corso delle vacanze, quando il lavoro è qualcosa di lontano e impensabile. Ma c’è un di più. Lo stesso affresco è di datazione incerta e di autore anonimo, cosa che ho trovato molto interessante: che non si possa datare, e non si possa attribuire un’opera che tematizza qualcosa di eterno come la morte, mi è sembrato un corrispettivo filologico di ciò che rappresenta. Senza data e anonima, del resto, è anche la morte (che l’affresco stesso sia la morte – la vacanza?).
I riferimenti effettivi all’affresco sono esclusivamente due: il paggio incurante del teschio a cavallo, e i due cani posti nel lato sinistro che guardano fuori quadro e sono inorriditi da qualcosa che non si riesce a vedere. L’incuranza dell’uno e l’orrore degli altri per ciò che non si vede mi ha condotto a chiedermi quanto ci sia di cosciente nell’arrivo della morte, come se nello stesso affresco fosse tematizzato il terrore (o la malinconia) per qualcosa che o non esiste o è invisibile. A partire da questo spunto, mi sono concentrato su tutto quello che manca, e, in primis, sulla sconvolgente assenza dei bambini. Sembra che la morte arrivi solo per gli adulti. Perché, infatti, non ci sono bambini? A questa domanda, forse, potrebbero rispondere solo gli incuranti o gli intimoriti e i preoccupati per qualcosa che non si vede. Come si può interpretare questa mancanza? È una speranza o un annullamento a priori? I bambini esistono? Sanno che muoiono? Io in realtà non credo nella speranza, quindi se dovessi dare una risposta, direi che l’assenza di bambini allegorizza l’idea di un cataclisma cosmico senza possibilità di proseguimento, senza futuro. Che muoiano solo gli adulti, in un affresco in cui sono rappresentate tutte le categorie umane, potrebbe significare che quella categoria umana non esiste neppure, quindi l’umanità non potrà proseguire una volta colpita tutta dalle frecce.
Come vedi, mi sono concentrato a interpretare le assenze, sia perché affascinato dalla possibilità che queste danno, sia perché credo che la poesia più che dire debba sottrarre; più che dire ciò che c’è, debba tematizzare, senza interpretare, quello che non si vede. Il testo e l’atto poetico, in sostanza, sono sempre una forma di sottrazione. Dire tutto e dire troppo è una colpa, e attribuisce all’io-poetante più facoltà di quante ne possieda. Attribuisce all’autore il diritto di aver capito qualcosa in più degli altri. In quanto autore di questo testo, dichiaro che non solo non ne so più di nessun altro, ma ne so meno.
So, però, chi è che parla, almeno in questa serie di testi. Tutta la sezione, infatti – e in particolare questo testo – è strutturata come se fosse un testo regolativo, o un dialogo: c’è un tu e qualcuno che dice tu. Ho immaginato che a parlare al tu-lirico, in questo caso, fosse il liutaio – quello che ha lo scorpione tatuato sul braccio. Quest’ultimo mi è sembrato, più del pittore autoritratto vicino ai supplici nel lato sinistro dell’affresco, l’allegoria di chi scrive o produce versi in generale. Lui, forse, in quanto “immortalato” lì, con i suoi segni, sa e può anticipare la rovina al tu che si specchia sull’affresco. Il liutaio può essere il solo ad attribuire al soggetto-vivente la colpa della propria reiterata esistenza e la responsabilità della morte degli altri. Da questo potrebbe, forse, derivare, il finale “e forse a scagliarle sei tu.” A pronunciarlo è, ancora, il liutaio; lo scaglia sul soggetto come una delle tante frecce scagliate dalla morte a cavallo. Asserendo che, nell’impassibilità da cui è “posto a sedere” il tu-lirico, al buio, nel palazzo-museo, comodo e, allo stesso tempo, ingabbiato, stia facendo morire – o non-morire, quindi non-liberare – gli altri, in attesa che una freccia, finalmente, colpisca anche lui.

ora se è giorno pensati al buio nel palazzo museo
a gambe incrociate seduto in mezzo alla sala
a chiusura a fine vacanza senza una data
come l’affresco. e perché non ci sono bambini
chiedilo al paggio di spalle che copre un futuro
e inquadra lo sfondo fiammingo e copre il fogliame.
chiedi al terrore dei cani da caccia ritratti
di fronte all’olezzo di mondo fuori cornice.
e tu continua a descrivere il tutto mancante
come se l’ecfrasi esplicita fosse una colpa.
perché non ci sono bambini e le frecce provengono
dal fuori che è il posto a sedere che abiti.
e forse a scagliarle sei tu.
