
Di che è mancanza questa mancanza, cuore, che a un tratto ne sei pieno? La domanda posta da Mario Luzi in questo verso iniziale di una delle sue ultime poesie, tratta da Sotto specie umana (Garzanti, 1999), centra a pieno il fulcro portante della drammaticità dell’essere e del sussistere, cioè la sproporzione fra la tensione indefinibile del bisogno del cuore dell’uomo e l’incapacità di quest’ultimo a soddisfarlo a pieno. La base di ogni volere è bisogno, mancanza, ossia dolore, a cui l’uomo è vincolato dall’origine, per natura. Venendogli invece a mancare oggetti del desiderio, quando questo è tolto via da un troppo facile appagamento, tremendo vuoto e noia l’opprimono: cioè la sua natura e il suo essere medesimo gli diventano intollerabile peso. La sua vita oscilla quindi come un pendolo, di qua e di là, tra il dolore e la noia, che sono in realtà i suoi veri elementi costitutivi (Shopenhauer).
E’ una “mancanza” allora che non rinuncia e mai rinuncia a dirsi, a svelarsi senza negare il vuoto che la circonda, originata direttamente dalla stessa esperienza del limite delle possibilità umane di comprendere il Mistero, di contenerlo entro i propri schemi senza ridurlo. Quell’ esperienza del limite che da sempre è stata matrice di poesia autentica, di quella poesia che non può fare a meno di sporgersi dall’orlo dell’abisso per dare un volto al buio, al nulla, a quella vertigine che stordisce dall’interno e dall’esterno di sé, essendo al contempo paura di cadere e desiderio di lasciarsi andare. La vertigine del vuoto con cui si sono ritrovati a misurarsi poeti da ogni epoca, si pensi al Secretum petrarchesco, all’ “Infinito” o al “Canto di un pastore errante dell’Asia” di Leopardi, a “La vertigine” di Pascoli, proseguendo per tutto il Novecento da Campana a Ungaretti, da Pavese a Montale, da Cattafi a Caproni, da Luzi a Sereni, dalla Cavalli a Viviani e su via fino ai giorni nostri.
Muta però la posizione individuale di ogni autore davanti a tale distanza incolmabile: basti pensare che se Luzi risponde a quella sua domanda invitando il lettore, nel verso conclusivo della poesia, all’attesa con l’imperativo “sii calmo”, Cesare Pavese avrebbe rilanciato con la famosa annotazione del 27 novembre 1945: “Qualcuno ci ha mai promesso qualcosa? E allora perché attendiamo?” Indagheremo più a fondo questa condizione dell’animo umano attraverso lo sguardo di tre poeti che, in maniera del tutto singolare e radicale, laddove pure sembrano mostrare simili sfere tematiche, hanno fatto di questa “vertigine del vuoto” il principale strumento della loro ricerca poetica sul dramma identitario del mondo e dell’uomo, tanto da influenzare indelebilmente le generazioni a venire.

Stiamo parlando di: Eugenio Montale, Bartolo Cattafi e Giorgio Caproni.
In una lettera datata 8 novembre 1917, Montale scriveva alla sorella Marianna: “Io sono amico dell’invisibile e non faccio conto che di ciò che si fa sentire e non si mostra, e non credo e non posso credere a tutto quello che si tocca e che si vede”. Questo affidamento all’invisibile, come conseguenza dello scetticismo nei confronti del reale, ha spinto sempre più Montale verso un pessimismo radicale, forse una maggiore consapevolezza, carico però di attaccamento alla vita che accade attimo dopo attimo, in tutte le sue “intermittenze”, per dirla con un termine caro al poeta. Un pessimismo che al tempo stesso accresce il disincanto all’origine della sua irrequieta ricerca metafisica e di quella sua costante interrogazione dell’atmosfera in torno e insita nelle cose, dell’Altro, propria di uno spirito profondamente religioso. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato/ l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco/ lo dichiari e risplenda come un croco/ perduto in mezzo a un polveroso prato.// Ah l’uomo che se ne va sicuro,/ agli altri e a se stesso amico,/ e l’ombra sua non cura che la canicola/ stampa sopra uno scalcinato muro!// Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,/ sì qualche sillaba storta e secca come un ramo./ Codesto solo oggi possiamo dirti,/ ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
Sono queste parole che, scritte nel 1925, si presentano come vessillo di un rifiuto nei confronti della dittatura fascista che in quel periodo consolidava il suo potere sullo Stivale. Nella strofa mediana della lirica, l’“uomo che se ne va sicuro”, incurante della sua ombra riflessa sui muri in rovina, sembra far tornare alla memoria la stessa tragedia invisibile del distacco, dell’alterità della scissione da se stessi e dal reale presente in un’altra famosa lirica del nostro poeta contenuta negli Ossi:
Forse un mattino andando in un’aria di vetro,/ arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:/ il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro/ di me, con un terrore di ubriaco.// Poi come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto/ alberi case colli per l’inganno consueto. / Ma sarà troppo tardi; ed io me n’andrò zitto/ tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.
L’uomo che guarda in faccia il vuoto, che anzi decide di attraversarlo, facendo così esperienza del limite estremo del cuore e della ragione, vede lo stesso vuoto divenire su di esso presenza, luogo tangibile di profondo smarrimento. Proprio a questa presenza mira lo sguardo del poeta che trova inediti termini concreti e visivi per descriverci l’immagine e la desolazione del “nulla”, del congedo assoluto. Dopo il Dolce Stilnovo e Petrarca -che cantando l’essenza dell’amore e i più oscuri turbamenti dell’animo, come ad esempio l’”accidia”, andavano instaurando il volgare, futura lingua italiana- , solo Leopardi, con “L’Infinito”, si era spinto tanto oltre a tracciare, attraverso il linguaggio, la sinopia di un vissuto interiore così indefinito.
Ed è proprio Leopardi infatti ad annotare nei suoi Canti a commento del verso “ove per poco / il cor non si spaura”: “nel quale pensiero, nella quale immaginazione” il cuore oscilla, “per la sensazione, istantanea ed inesprimibile, che l’infinito coincida col nulla”. Ma in quel “terrore di ubriaco” della lirica montaliana, come nello strepito del cuore ne “L’infinito” leopardiano, si intravede la soglia, il limite estremo della poesia di Montale: il ”varco”, la “distanza che divide”, “le immagini” che “portano scritto più in là”, “la maglia rotta nella rete”.

Al di là di Bergson, Scestov e Boutroux, indicati dal poeta stesso come intellettuali letti negli anni di stesura degli Ossi di seppia, si fa incombente la lezione di Schopenhauer: “Scrivendo il mio primo libro […] ubbidii a un bisogno di espressione musicale. Volevo che la mia parola fosse più aderente a quella degli altri poeti che avevo conosciuto. Più aderente a che? Mi pareva di vivere sotto una campana di vetro, eppure sentivo di essere vicino a qualche cosa di essenziale. Un velo sottile, un filo appena mi separavano dal quid definitivo. L’espressione assoluta sarebbe stata la rottura di quel velo, di quel filo: la fine dell’inganno del mondo come rappresentazione” (Montale). Allora il “prodigio” che schiude la “divina indifferenza” che porta “spesso il male di vivere”, del “nulla” pieno, sarebbe dunque anche la morte della poesia, che dopo aver detto, con “qualche sillaba storta e secca”, “ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”, si licenzia per sempre. Per meglio intendere come questo poeta percepisca il fare poetico e il valore che attribuisce alla stessa ricerca poetica, sarà utile riportare un estratto di un’intervista fatta all’autore nel 1951.
I quesiti interessano il modo in cui Montale ha percepito e vissuto il periodo di stesura degli Ossi e Le occasioni, quello compreso cioè tra le due Grandi guerre mondiali: “L’argomento della mia poesia è la condizione umana in sé considerata; non questo o quell’avvenimento. Ciò non significa estraniarsi da quanto avviene nel mondo; […] ma non posso dire che se i fatti fossero stati diversi anche la mia poesia avrebbe avuto un volto totalmente diverso. […] Avendo sentito fin dalla nascita una totale disarmonia col mondo che mi circondava, la materia della mia ispirazione non poteva essere che quella disarmonia. Non nego che il Fascismo dapprima, la guerra più tardi, e la guerra civile più tardi ancora mi abbiano reso infelice; tuttavia esistevano in me ragioni di infelicità che andavano molto al di là e al di fuori di questi fenomeni.” Il forte senso di estraneità, di anacronismo e dissonanza nei confronti del reale, il “male di vivere” un’esistenza irrealizzabile di cui si è contemporaneamente complici e vittime, subita come “prigione”, come una muraglia “che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia”, occupano la produzione di Montale fin dal suo esordio attraversando momenti diversi.
Se all’inizio del suo percorso di formazione vi era nel poeta la speranza che in tale disarmonia potesse verificarsi un evento salvifico in grado di ridonare significato vero e proprio alle cose e alla realtà, successivamente, con le dittature e gli orrori delle guerre, la possibilità di salvezza ormai disillusa viene tutta affidata -in parte già negli Ossi ma più forte ne Le Occasioni-, ad un “tu” femminile ed angelico, mutuato dal modello stilnovistico o, meglio ancora, dantesco. Ispiratrice di Montale è Annetta o Arletta (come in seguito farà con Clizia o Dora), donna che il poeta frequentò da giovane senza più ritrovare in seguito, se non nei suoi versi. La donna riveste per il poeta l’unica possibilità di dare un senso al trascorrere del tempo e di riconquistare la propria identità, sebbene esso non riesca a dare equilibrio e consistenza al ricordo di lei. La donna viene allora idealizzata dall’autore poiché, ormai perduta, egli non può far altro che vagare nel mondo alla ricerca di labili tracce che la riportino alla sua memoria. Si reca perciò al limite estremo, al luogo di confine dove il “calcolo dei dadi più non torna”, detto “La casa dei doganieri”, per tentare di gustare di nuovo, anche solo per un istante, la dolcezza del ricordo. Ma il vento del tempo porta via con sé ogni apparente certezza trascorsa e disperde la memoria come una “bussola” impazzita che gira e rigira su stessa nell’oscurità: Libeccio sferza da anni le vecchie mura/ e il suono del tuo riso non è più lieto:/ la bussola va impazzita all’avventura/ e il calcolo dei dadi più non torna./ Tu non ricordi; altro tempo frastorna/ la tua memoria; un filo s’addipana./ Ne tengo ancora un capo; ma s’allontana/ la casa e in cima al tetto la banderuola/ affumicata gira senza pietà./ Ne tengo un capo; ma tu resti sola/ né qui respiri nell’oscurità. Anche una luce fioca in lontananza sembra ormai un fragile incanto di fronte all’inesorabile trascorrere del tempo: Oh l’orizzonte in fuga, dove s’accende/ rara la luce della petroliera!/ Il varco è qui? (Ripullula il frangente/ ancora sulla balza che scoscende…)/ Tu non ricordi la casa di questa/ mia sera. Ed io non so chi va e chi resta.
La donna e la realtà sono ormai diventati inafferrabili, simili ad un groviglio di pensieri che lentamente sprofondano nel “nulla” assoluto. Quella di Montale è una negatività che, anche se in vano, ricerca la positività, la salvezza, e proprio nella negazione totale di quest’ultima offre una grazia riservata a chi sarà in grado di superare stesso per fuggire dalla propria individualità. L’autenticità della poetica montaliana, infatti, nasce come “compromesso” tra la tradizione letteraria e le nuove istanze della letteratura novecentesca. Mentre Ungaretti, ad esempio, si distacca dalla tradizione spingendo la parola fino alla sua estrema nudità, al massimo del suo laceramento, facendo di essa uno strumento di liberazione capace di attingere dalle fonti dell’assoluto, per Montale questa risulta una soluzione troppo fiduciosa e banalmente consolatoria. Egli ritiene che tra l’uomo e l’assoluto sussista una realtà ineliminabile che Ungaretti, invece, tende a trascendere o addirittura ad elidere.
E’ il mondo della realtà fenomenica che comprende la natura degli eventi e della Storia in cui essi stessi risultano inseriti, e nella quale è quasi impossibile individuare uno spiraglio di verità da cui poter derivare risposte definitive a quei quesiti che l’uomo quotidianamente si pone. Alla realtà fenomenica però, sempre si contrappone una realtà metafisica che implica il destino ultimo dell’uomo. Un destino, un mistero che la ragione e le sole mani umane– neppure dell’intellettuale a cui si voleva da secoli idealmente affidato questo compito-, riescono a contenere fino in fondo; un destino che solo potrà realizzarsi in definitiva in un’ulteriore dimensione all’uomo sconosciuta e tale da trascenderlo. La parola allora per Montale non può aspirare a raggiungere diametralmente l’assoluto, come in Ungaretti, ma deve percorre in tondo i lati del cerchio, della “ruota”, in quanto essa deve prima confrontarsi con quella realtà che costituisce un ostacolo costante, quella fitta “nebbia di sempre”, la “rete” nella quale si resta inevitabilmente impigliati. Non è certo un caso se “termine”, oltre che sinonimo di “parola”, lo è al contempo per “limite”, “confine”, o ancora, omettendo il prefisso d’insieme, “fine”. Ciò, nonostante, risulta l’unica maniera possibile di porsi di fronte al “mistero” dell’esistenza nel tentativo di avvicinarlo. Così, la parola per Montale non può fare a meno di toccare oggetti definiti e concreti, stabilendo tra di essi una densa trama di relazioni cui fa capo la stessa voce poetante e di cui fine ultimo è scoprire con meraviglia la direzione e il senso della propria identità, del proprio stare a questo mondo.
La sua scelta letteraria concerne dunque particolari quotidiani, “piccole cose”, fatti anche minimi che danno forma a profonde condizioni interiori, ad elementi di una realtà intimamente ed esteriormente misera che l’uomo facilmente ritrova intorno a sé in qualunque momento dei suoi giorni. Voci, immagini, natura, oggetti e ricordi diventano man mano “emblemi” in cui è trascritto, in forme criptiche ed oscure, il destino dell’uomo, nell’infelicità di una condizione e di una condanna esistenziale che non può offrire certezze né illusioni. E’ un destino che l’uomo non può accettare ma contro cui neppure v’è ribellione che valga la pena perseguire. In esso si riflette tutto il senso di “estraneità”, di “vacuità” dell’uomo contemporaneo, da cui deriva l’emergenziale bisogno del “varco” celebre de “La casa dei doganieri” che apra la strada senza remore al mistero, alle “cose arcane e segrete” suggerite dall’etimo stesso della parola, e già insite nel consueto fluire della vita.

Anche in Cattafi, come in Montale, influente nei versi del primo, oggetti ed immagini si fanno veicolo di stati d’animo, di condizioni molteplici e contrastanti della coscienza umana, non che denuncia sociale verso un mondo che sta lasciando dietro di sé ogni etica e valore.
Le parole spese da Sereni negli atti del Convegno di studi su Bartolo Cattafi testimoniano la stessa montaliana attenzione all’“invisibile”, già rintracciata da Sereni nell’”essenza” della poesia di questo autore, “che vede il non detto e dice il non visto, ossia apre il vuoto del nostro vedere e lo riempie di segni. Partita come poesia essenzialmente visiva, è diventata ben presto visionaria, la più visionaria che io conosca, immune da interferenze mentali e calcolate”. Molti dei versi di Cattafi sono dedicati al tema del viaggio, geografico e al tempo stesso esistenziale, come metafora della conoscenza di sé e del mondo; viaggio che sempre fa le sue prime mosse da una tabula rasa, da un “grado zero”, come scrive nella poesia “Accensione” contenuta ne L’osso, l’anima (1964): Non conosco il sistema,/ forse lo sanno i santi/ i saggi, i veggenti forsennati,/ i poveri di spirito/ poveri fino alla fine/ portatori di fuoco./ Non capisco il foglio/ d’istruzioni per l’uso/ induzioni e correnti,/ valvole, bobine,/ magneti bagnati/ in fondo al mare. Per Cattafi, anche nel disincanto, la vita persiste come avventura indecisa e imprevedibile che lascia emergere con forza smisurata quella malinconica nostalgia che è necessità di ricongiungimento con la propria identità, con la propria origine. Il viaggiatore di Cattafi è un uomo impossibilitato a comprendere “le istruzioni per l’uso”, ad accettare gli eventi per il semplice fatto che accadano. E’ un viandante che rischia di smarrirsi in spazi sconfinati o di naufragare nel groviglio della propria confusione, dove, come ricorda Kafka, si è poco più che bestie prigioniere della propria esperienza. Ma il poeta, anche nel silenzio più vasto –che presto diviene rumore di fondo-, non può fare a meno di uscire allo scoperto: Avanti, sputa l’osso:/ pulito, lucente, levigato,/ senza frange di polpa,/ l’immagine del vero,/ ammettendo che in questo/ unico osso avulso da contesto/ allignino chiariti, concentrati,/ quesiti fin troppo capitali./ Credo che tu non possa/ farcela; saresti/ cenere nella fossa,/ anima da qualche parte. La vita non è questione da affrontare con calcoli e misurazioni, ma piuttosto con la lama di un coltello: Inutile farla lunga/ girarla e rigirarla/ allo spiedo, al rovello/ dell’attenta osservazione,/ l’analisi, la sintesi,/ i discorsi sul metodo./ Si muore dalla noia./ C’è un modo d’aggredire la questione:/ col coltello (“Metodologia”).
Cattafi è scettico nei confronti della possibilità di realizzazione di una conoscenza maturata dal sondaggio di abissi mentali e baratri dell’animo. Coglie piuttosto la continua intermittenza tra i più alti aneliti della ragione e buie voragini che ne costituiscono il rovescio, l’altra faccia, le sue ambiguità. Questa ironia, quest’atteggiamento sarcastico verso ogni effimera pretesa eroica, non si risolve però in un semplicistico cinismo autoreferenziale e sicuro di sé. Se è auspicabile “atterrare lo spirito che vola” capovolgendo quel processo che la coscienza umana produce quando si pone come padrona di sé nei confronti del mondo e degli eventi, nello stesso tempo è impossibile conservare una stabile e pacifica condizione terrestre di equilibrata contiguità alle cose. Una perenne inquietudine, un’esuberanza vitale destinata ogni volta a dissiparsi vanamente, fanno sì che il movimento di trasfigurazione, di innalzamento teorico, di rottura di ogni immediatezza, si ripresentino ad ogni passo. A ricordalo è un testo tratto da L’allodola ottobrina (1979): Queste cose terrestri / che scoppiano tra i piedi come rose / le raccatti ammirato le porti / ai più alti ripiani / e perdi il lume degli occhi / non vedi / le altissime cose / cadute in frantumi. Questa poesia riconduce ad un aspetto centrale della poesia e della riflessione di Cattafi, cioè a quell’intuizione mistica della sostanziale identità delle cose, della sostanziale identità di ciò che sta in “alto” e di ciò che sta in “basso”. L’intera produzione cattafiana è percorsa da uno straordinario slancio spirituale e trascendentale fin dalla prima conversione dell’autore. Tant’è vero che per dare l’idea di una ascesa, di un movimento dell’animo verso l’alto, il poeta utilizza il termine “ripiani”, quasi facendoci provare la stessa tensione del corpo, come se anche nell’atto di riporre qualcosa verso l’alto si mostri il desiderio di voler andare più su, più in là.
Se dunque la poesia di Montale mette in scena senza illusioni e inganni, la condizione, insomma, di colui che ha perduto ogni permesso di transito dal mondo “sensibile” (particolare) a quello “ideale” (assoluto), lasciando però che sussista un minimo spiraglio che quel “nulla”, percepito dietro “l’inganno consueto”, possa divenire elemento profondamente acquisibile in termini di giudizio formativo sulla propria esperienza, Cattafi ne da un’effettiva dimostrazione. In Cattafi l’immagine perturbante del paesaggio quale retroscena in cui natura e cultura si mescolano indistintamente, costituisce un precipuo ritorno tematico: Tavoli e sedie vuote sulla ghiaia/ un giardino un viale/ foglie legate a un filo/ immobili nell’aria/ e davanti/ fra il proscenio e loro/ i presagi gonfiano il sipario (“Scena”). Già lo stesso titolo “Scena” individua il luogo tipico della farsa teatrale, della finzione e dell’illusione per antonomasia, ma contemporaneamente “scena” è quella porzione massima di realtà che qualcuno può percepire come sfondo di un evento reale, o come orizzonte del mondo osservato in sé quasi fosse un panorama. Ci viene allora lapidariamente presentato uno scorcio insulso: oggetti inerti in un ambiente desertico, ossia sedie e tavoli in un giardino.
La soppressione delle virgole, già accaduta nella decisiva sequenza montaliana (“alberi case colli… ”) di “Forse un mattino andando”, rende in qualche modo indeterminato l’ordine dell’enumerazione, suggerendo che i suoi componenti sono personaggi senza copione che possono combinarsi ad libitum, o forse persino vanificarsi, poiché il vincolo sintattico della virgola, che isola e separa, non è più relativa. Il “Tu”, che nelle ultime raccolte di Cattafi irromperà “spudoratamente” nei suoi versi, da L’allodola ottobrina (1979) a Chiromanzia d’inverno (1983), ne L’Osso (1964) e in Marzo e le sue idi(1977) non è ancora del tutto tematizzabile o per lo meno viene evocato soltanto attraverso l’aggettivo possessivo “tuo”, come accade per la poesia “Le tue dita”. Dopo il silenzio del biennio ‘74- ‘76, seguito alla stesura dei testi contenuti in Marzo e le sue idi, qualcosa nel poeta cambia radicalmente. L’allodola ottobrina, l’ultima raccolta licenziata da Cattafi, mantiene su di sé i segni evidenti di questo mutamento. Composta di poesie scritte, come le 18 dediche, nel biennio ‘76-’77, inizia con una lirica significativa per l’intera raccolta, “Cammino”, che sembra segnare una svolta decisiva nella poetica del nostro autore. Compare, finalmente, una perentoria invocazione ad un “tu”, capace di imporre alle cose “una dolce chiarezza”, tanto che i versi finali della lirica assomigliano ad una certezza raggiunta: e l’enigma è sciolto / tutto in un filo / il cammino allungato. Ma così non è. C’è ancora “Un punto” da risolvere, un punto / un solo punto che l’intelletto non afferra e che diventa nuovamente emblema del costante ravvedimento dell’enigma esistenziale che invece si credeva concluso. L’abisso dell’esistenza non è affatto eluso.
Gli uomini possono anche percepirsi “costretti” a una crosta di terra/ a una sosta d’insetto (“Costrizione”) o anche sentirsi rami secchi/ inutili inerti/ inetti anche all’incendio (“Dodici dicembre 1976”). Tuttavia proprio questa diventa la condizione favorevole all’attesa più autentica: […] aspetto a questo vento di dicembre/ chi già venne a sospingermi sul ciglio/ a buttarmi sul fondo degli abissi/ chi mi fece salire a colpi d’ala/ oggi/ sotto la sferza del suo aspetto (idem). Chi sospinge sull’orlo dell’abisso è colui che fa risalire a colpi d’ala. Tutto allora acquista un’energia e una fiducia proprio sull’orlo dell’abisso della propria esistenza e del proprio vissuto individuale: E’ qui che Dio m’assiste/ lungo la parte più assurda della curva/ saldamente incollato/ su questa traiettoria/ ad occhi chiusi vinco/ la vertigine il vuoto la mia storia (“E’ qui che Dio”). Se ne L’Osso o ne L’aria secca del fuoco (1972), la realtà tangibile gli appare come “osmosi misteriosa ed allucinata di fisicità e astrazione in un’unica poltiglia finale” (Maccari) in Chiromanzia d’inverno, pubblicato postumo con la supervisione di Raboni, la percezione è completamente rovesciata e la prospettiva vertiginosamente proiettata in avanti: Un piede di qua / e l’altro di là / tutto è lieve e smussato / pane vino / con un mezzo sapore d’eternità (“Di qua, di là”).
La gravità degli eventi, ora davvero, sembra essersi assestata, accomodata, come dissolta. Ce lo riconferma “Prima di morte” in cui, si legge: scompare ogni puntiglio / viene meno / il punto da ribattere. Sembra che questo sia lo stesso “punto” che ne L’allodola ottobrina, persisteva, seppur nella sua nominazione, ad essere dichiarato inflessibile e incompreso. Lo suggerisce la lirica Libertà: Oh sì non alzo/ abbasso le tue ali/ ai Tuoi piedi mi metto/ libero lieve occhi socchiusi/ aspetto assorbo accetto/ dall’ultimo al primo i Tuoi soprusi. E il poeta, prima di spegnere per sempre la sua voce, ammalatosi di cancro, ci lascia il suo ultimo respiro In te: In te in te confido/ tutto ho rubato al mondo/ sei il Cubo la Sfera il Centro/ me ne sto tranquillo/ tutto t’è stato ammonticchiato dentro.
Sembra uno sguardo consuntivo su tutta l’esperienza poetica e vitale fin qui trascorsa se si scopre che, nel risaputo “cerchio già chiuso”, Dio è insieme “Sfera” e “Centro”, allora il poeta può, senza più ripensamenti, dichiararsi davvero “recluso nel suo bene”. Diventa allora evidente la prossimità tematica ed iconografica, oltre che con Montale, pure tra Cattafi e Caproni.
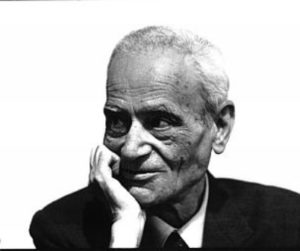
Giorgio Agamben ha ben definito questa attitudine di Caproni di mancanza di un fine che superi la Storia e gli eventi riempiendoli di significato, inserendola nella sfera dell’ “ateologia”: “Poiché propria dell’ateologia poetica, rispetto a ogni teologia negativa, è la singolare coincidenza di nichilismo e prassi poetica, per cui la poesia diventa il laboratorio in cui tutte le figure conosciute vengono disarticolate per far posto a nuove creature para-umane o subdivine.” Se prevalente in Caproni è la cantabilità del verso, assente in quello arido e incedente di Cattafi, la sua predisposizione si traspone in un esercizio che predilige il rincorrersi di echi e guaiti, di voci e figure in lamento. In questo universo di “colpi che rimbalzano sul vuoto per raggiungere esatti e micidiali chi ha scoccato la freccia”, di brume evanescenti, si pensi anche a Il franco cacciatore, si delineano sagome definite e situazioni cariche di particolari dove “nulla” però sembra davvero prendere le mosse. In Cattafi la prassi è invece quella del dato visibile e concreto, e perciò della “scena” in azione, fatti di gesti e di segni, nella cangiante fantasmagoria di una continua corrente metamorfica.Nello stesso anno di pubblicazione de L’osso, l’anima (1964), considerato strutturalmente il primo volume davvero autonomo di Cattafi, Caproni pubblica il suo Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee. In entrambi i volumi l’impianto metaforico verte attorno alla figura del viaggiatore e del tema del viaggio. Caproni, come Cattafi, predilige procedere per enigmi e paradossi. Simile è l’assetto nichilista che fa di questo viaggio oscuro e fittizio la metafora della vita stessa; dove, pure, è la stessa vita a farsi metafora di se stessa. Il moltiplicarsi di itinerari, tra fughe e ritorni repentini, prolunga la distanza avvertita da Cattafi tra “proscenio” e “scena”, tra l’occhio e il suo orizzonte, che è frequente leitmtotiv anche dei componimenti caproniani, seppure disposta su un piano differente che pone dirimpetto nome e corpo, termine e oggetto. Come accade, ad esempio, nei “Due Madrigaletti” de Il conte di Kevenhüller (1986): (Appassionatamente)/ Mio nome, avvicinati./ Stringiti al mio corpo./ Fa’ che nome e corpo non siano,/ per me, più due distinti.// Moriamo insieme.// Avvinti. (I); (Sempre con cuore)/ Bruciamo la nostra distanza./ Bruciamola mio nome./ Cessiamo di viverla come/ il sasso la sua ignoranza.”
In Cattafi non è presente la caccia continua o la fuga, per boschi o ripide alture, di prede e cacciatori che spesso e volentieri si trovano a dividere lo stesso corpo e lo stesso cuore. In Cattafi, il susseguirsi degli eventi è tutto teso al raggiungimento della fine, di un disegno finale “a sorpresa”, quasi fosse un estremo smascheramento dei propri sospetti, delle proprie congetture; oppure la vicenda si spezza per lasciarne emergere un’altra di contrario senso e natura. Catalizzando in ultima analisi la nostra attenzione su Caproni, fulcro centrale della sua poesia, sia in senso temporale che di valenza lirica, sembra essere rappresentato dal volume Il seme del piangere (Garzanti, 1959) ora contenuto ne L’opera in versi (Mondadori, 1998). Il titolo, tratto dal poeta da alcuni versi del Purgatorio di Dante, risulta piuttosto simbolico in quanto concerne i versi in cui Beatrice esorta Dante a farsi coraggio e, ormai purificato, a “porre giù” “il seme del piangere”; ora che conosce la verità che lo salva da ogni smarrimento e motivo del suo pianto. Interamente dedicato ad Annina -la Anna Picchi madre del poeta, protagonista principale degli innamoranti “Versi livornesi”-, il volume riporta il tema fondante della poesia caproniana, strettamente legato, come si diceva, a quello del viaggio, e cioè la circolarità del moto inteso come ritorno circolare al punto di partenza, che finisce – da Il franco cacciatore a Il conte di Kevenhuller al postumo Res Amissa– per coincidere con il “nulla”, il non essere, l’”ontologia negativa” di cui scriveva Calvino, e poi ripresa da Mengaldo, a proposito di Caproni. Basti pensare ai versi celebri del “Biglietto prima di non andar via”, contenuto ne Il Franco cacciatore: Se non dovessi tornare, / sappiate che non sono mai / partito. // Il mio viaggiare / è stato tutto un restare / qua, dove non fui mai”. Dove nessuno può affermare chi sia il perseguitato e chi il persecutore: “Un semplice dato:/ Dio non s’ è nascosto./Dio s’ è suicidato.
Un Dio che il proprio cuore ricerca instancabilmente ma che la ragione sembra impossibilitata ad accettare, a contenere nei suoi schemi. E’ una circolarità quella di Caproni che sempre ritorna su se stessa, senza via di scampo -se non nell’ironia-, proponendoci un’inquietante allegoria “vuota”, come in Kafka o Benjamin, letti dal poeta, dove l’inseguito insegue / il suo inseguitore” e dove “la preda che si morde / la coda… / La preda / che in vortice si fa preda / di sé… (“Il conte di Kevenhuller”). In Caproni la metafora non ha più una carica tale da lasciare spazio ad un unico significato inscrivibile in un ordine di verità generale e condiviso, come in Dante; qui tutto sembra condurre al nulla e alla vanificazione di ogni senso, a quella che Caproni chiamerà in un altro luogo la “Dedizione”, cioè la consegna completa al nemico. Ma in realtà non è semplicemente così.
La madre ragazza Annina, dai pensieri “alberati e freschi”, che volava in bicicletta per Livorno, la cui esistenza è tutta nella giovinezza, ci consegna una memoria poetica intatta che non avrà mai fine. Scrive Mengaldo: “la più splendida fra le sue invenzioni di narratore, la biografia fantasticata della madre giovinetta con conseguente slittamento edipico del rapporto madre-figlio (‘suo figlio, il suo fidanzato’)”. Se tutto allora ritrova il suo senso, e ci salva dal nulla assoluto, questo avviene grazie all’incanto di una scrittura “fine e popolare” che non ha eguali: Mia mano, fatti piuma:/ fatti vela; e leggera/ muovendoti sulla tastiera,/ sii cauta. E bada, prima/ di fermare la rima,/ che stai scrivendo d’una/ che fu viva e fu vera./ Tu sai che la mia preghiera/ è schietta, e che l’errore è pronto a stornare il cuore./Sii arguta e attenta: pia./ Sii magra e sii poesia/ se vuoi essere vita./ E se non vuoi tradita/ la sua semplice gloria,/ sii fine e popolare/ come fu lei – sii ardita/ e trepida, tutta storia/gentile, senza ambizione.// Allora sul Voltone,/ ventilata in un maggio/ di barche, se paziente/ chissà che, con la gente,/ non prenda aire e coraggio/ anche tu, al suo passaggio (“Battendo a macchina”). Come ne Il seme del piangere anche nel caso dei sopracitati Il franco cacciatore e Il Conte di Kevenhuller, lo spazio, con i suoi paesaggi magri ed enigmatici (il bosco, il fiume, il muro, i sassi, la valle ecc. ecc.), con i suoi interni dalle linee precise e schematiche (la latteria, l’osteria), scandagliato e rovistato dalle controparti e alibi molteplici del poeta, si riempie di silenzi violenti ed esplosivi, di rantolii, che cercano di mettere nuovamente alla prova il discorso sul “niente”: Un soffio… // (Non è paura.) // Di tutto l’avvenimento, in mente / appena // (a pena) // un niente (“Un niente”).
Così la morte, massima “ontologia negativa”, non potendo essere né detta né scorta con lo sguardo, si fa silenzio. Come nota Salvatore Ritrovato in suo articolo, “anche il paradosso in molti testi di Caproni esprime la possibilità di parlare ancora del mondo e di cercare in questo un Poco di ragione. Si prenda, per esempio, Ritorno (Il muro della terra): Sono tornato là / dove non ero mai stato. / Nulla, da come non fu, è mutato. / Sul tavolo (sull’incerato / a quadretti) ammezzato / ho ritrovato il bicchiere / mai riempito. Tutto / è ancora rimasto quale / mai l’avevo lasciato.
Se Caproni ritenesse la ragione uno strumento del tutto inadeguato a comprendere il mondo, lo sbocco non sarebbe il paradosso, il ragionamento stringente, la conseguenza non conseguente o incongruente, ma il silenzio totale, in ogni senso. Al contrario, il paradosso, l’aforisma, l’antifrasi, il contraddetto rendono certi di quel Poco – poco di ragione – che all’uomo resta. Questo non è “minimalismo”, o anti-illuminismo o anti-umanismo, né d’altra parte razionalismo o logocentrismo […]: è tagliente ed astuta paradossalità della poesia.” E’ Caproni stesso ad affermare che non c’è “il nulla, ma certamente c’è l’inconoscibile, c’è l’altra terra ignota, ci sono quelli che il poeta chiama “i luoghi non giurisdizionali dove alla nostra ragione non è lecito entrare e capire”, aggiungendo che: ”noi chiamiamo “nulla” ciò che non possiamo conoscere”.
